Gli assassini della memoria
GLI ASSASSINI DELLA MEMORIA
Il concetto di continuum storico non lega soltanto i fatti in un lungo elenco cronologico, ma, preso complessivamente, vuole significare che «è il passato che ci ha fatto come siamo qui e ora; ed è la radice dell’importanza che il potere politico ha sempre assegnato al controllo del passato come strumento privilegiato per il controllo del presente1». Non casualmente, tra i principali elementi caratteristici dell’uso pubblico della Storia, Gallerano cita la costruzione «attraverso il passato, del progetto e di una profezia del futuro», confermando quanto già affermava George Orwell2, non molto tempo prima: «Chi controlla il presente, controlla il passato. Chi controlla il passato controlla il futuro». Anche in questo caso, il senso è che, per legittimarsi, chi gestisce il potere ha bisogno di un’identità che abbia radici nel passato; ma, subito dopo, Orwell avverte: chi ha il potere di manipolare la Storia del passato a proprio favore, sarà tentato di farlo anche per il presente, con il preciso intento di ipotecare il futuro.
Ciò è sempre vero, ma lo è ancor di più per i regimi totalitari.
A oltre settant’anni dal 25 aprile 1945, c’è ancora chi pretende di negare o di banalizzare il totalitarismo fascista, mentre, definendosi «revisionista», fa parte, invece, della categoria dei negazionisti che cercano di colpire di nuovo le innumerevoli vittime del fascismo nella loro memoria individuale. Lo storico e filosofo francese Pierre Vidal-Naquet3 li chiama «gli assassini della memoria»4, perché vuole ricordarci che la Storia è fatta anche dell’intreccio delle memorie delle vittime e di quelle dei testimoni e, proprio per questo, l’operazione dei revisionisti è particolarmente vile e spregevole.
Ma se si può assassinare la memoria, si può assassinare anche la Storia?
Contrariamente ai luoghi comuni, la Storia non la fanno né i potenti né i vincitori; la Storia la fanno i documenti che, poi, gli storici studiano, interpretano e raccontano. La documentazione della Storia recente è così ampia che è difficile anche solo immaginare che possa essere distrutta, nascosta o manipolata. Tra l’altro, gli stati totalitari, in genere i più tentati dalla manipolazione, sono anche quelli che, di solito, hanno archivi bene organizzati, in cui la documentazione è ben curata e ciò, loro malgrado, permetterebbe agli storici di rimettere le cose al loro posto; ma il problema, in quei regimi, è il diritto di accesso agli archivi.
Verità storica e revisionismo storico
Gli storici cercano di stabilire la verità storica, determinando obiettivamente l’accaduto. Considerano il contesto e le circostanze di un evento o di un documento. Interpretano l’evidenza ed espongono le proprie opinioni, sempre consapevoli che altri storici potrebbero esaminare lo stesso materiale e, senza alcun intento fraudolento, giungere a conclusioni diverse. Gli storici sanno che, con l’acquisizione di nuove fonti e nuovi documenti, le loro verità potrebbero essere accantonate. In parole povere, nella narrazione storiografica non c’è mai una «pistola fumante» in grado di indicare con certezza il responsabile di un determinato fatto storico, né le verità storiche sono scolpite sulla pietra, come le tavole della legge, e neppure si possono misurare come la distanza dalla terra alla luna5. Con la pubblicazione del loro lavoro, gli storici lo mettono a disposizione della comunità scientifica perché ne possa fare l’uso più appropriato, secondo le regole scientifiche stabilite e accettate dalla comunità stessa.
Lo storico ha il dovere di rispettare i fatti e di accertarne l’esattezza, cercando di inserire nel proprio quadro tutti i fatti conosciuti, qualunque sia il loro senso, che abbiano comunque un certo rilievo per il tema della sua ricerca o per l’interpretazione che egli ne può dare. Soprattutto, lo storico sa che non c’è mai una sola causa che determina un avvenimento, bensì un insieme di esse, ciascuna delle quali andrà indagata per cercare di introdurre un ordine, stabilire una gerarchia per indagare i rapporti che le legano e poter indicare, in ultima analisi, quali a suo parere debbano essere considerate decisive. Infine, lo storico deve essere consapevole che ogni discussione storica ruota intorno al problema della priorità delle cause6 e che deve evitare ad ogni costo il c.d. «presentismo», che è il rischio di interpretare il passato con gli occhi e le conoscenze del presente.
La storia fatta coi piedi7
Coloro che si riempiono la bocca con l’espressione «verità storica» o – peggio ancora – con «verità» senza aggettivi, dovrebbero leggere un saggio di agile lettura, considerato una pietra miliare della riflessione sulla ricerca storica. È il famoso Apologia della storia o Mestiere di storico, scritto da uno dei più grandi studiosi del Novecento, Marc Bloch.
Membro della Resistenza francese e professore di storia alla Sorbona, fondatore con Lucien Febvre della rinomata rivista di storia “Annales d’histoire économiques et sociales”, Bloch fu arrestato dalla Gestapo nella primavera del 1944, torturato e infine fucilato insieme ad altri 26 partigiani. Apologia della storia uscì postumo, nel 1949. In quel libro, Bloch parla del metodo critico, di come maneggiare i documenti storici e di come nascano i falsi e gli errori.
Ecco, in estrema sintesi, alcuni tra i più utili insegnamenti che si possono trarre dal libro di Bloch.
- L’autenticità di un documento non implica l’autenticità del suo contenuto. Un foglio trovato in un archivio può essere autenticamente del 1945, e al tempo stesso essere pieno di asserzioni prive di riscontro e di basi fattuali. … Il passato non conferisce veridicità a un documento, una panzana non diventa vera solo perché d’annata. Ripetere che un documento «è autentico» senza distinguere tra questi due aspetti, anzi, confondendoli sistematicamente, è roba da storico della domenica… oppure da mestatore.
- Nemmeno l’archivio conferisce veridicità a un documento, come non gli conferisce autorevolezza: gli archivi raccolgono di tutto, se un documento viene trovato in un archivio rinomato, non per questo dice il vero, né il suo contenuto ha alcun “sigillo di garanzia”. Che un documento trovato negli archivi della Farnesina venga definito tout court come «un documento della Farnesina» è, nella migliore delle ipotesi, un errore marchiano; nella peggiore, un miserabile espediente.
- Ancor più cautela richiedono le testimonianze orali basate su ricordi e sulla frase «Io c’ero». L’esserci stato non conferisce autorità a un testimone né veridicità al suo racconto: bisogna capire dove è stato, e come, in quale condizione d’animo e a quanti “gradi di separazione” dall’evento che racconta. Non è nemmeno necessario che un testimone sia mendace perché la sua testimonianza sia priva di riscontri: ogni storico serio sa che i ricordi si modificano nel tempo, e l’esperienza di un testimone è sempre soggettiva e parziale. Per questo le testimonianze non vanno prese come oro colato ma indagate, smontate, confrontate tra loro. Soprattutto quando si parla di guerre, di tragedie, di eventi osservati in momenti di «violento turbamento emotivo», spiega Bloch, l’attenzione dei testimoni è «incapace di concentrarsi con sufficiente intensità su punti ai quali lo storico giustamente [attribuirà] un interesse preponderante».
- Tutte queste trappole si fanno ancora più insidiose quando il ricordo dell’evento è in realtà ricordo del racconto dell’evento, cioè la testimonianza è di seconda mano, fornita dal figlio o dal nipote del presunto testimone diretto, o è ancor più lontana dai fatti. Per capirci: uno che dice «in paese si è sempre detto» o frasi simili, molto a fatica può essere definito un testimone. Se il ricercatore continua a chiamarlo così, o è disonesto, o è stolto… o entrambe le cose.
- Senza questo approccio critico nei confronti delle testimonianze, si rimane al dettaglio che colpisce l’attenzione del profano, e si finisce per riportarlo senza filtri. Se un tale mi dice che sua sorella (nemmeno lui: sua sorella!), giocando su un prato quand’era ragazzina trovò un piede umano, io ho il dovere di chiedergli di approfondire: che anno era? Sua sorella chiamò i carabinieri? Fu perlustrata l’area? Si è poi scoperto di chi fosse quel piede? Non è altro che il vaglio giornalistico innescato dalla proverbiale “seconda domanda”. È l’ABC. Ma se non faccio la seconda domanda, quel piede resta un dettaglio macabro, morboso. Un dettaglio privo di contesto, insignificante e inutilizzabile a fini storiografici, ma molto buono per impressionare i lettori.
- Una volta trovato un documento, per prima cosa devo chiedermi se sono il primo ad averlo trovato. Dopodiché, devo subito inserirlo nel contesto delle conoscenze e acquisizioni storiografiche sull’argomento. Solo a quel punto potrò divulgarlo e parlarne in modo serio e coerente. Se lo divulgo prima di ogni cosa, e in modo sensazionalistico, aggiungendoci gli errori trattati nei punti 1 e 2 e cercando pezze d’appoggio in testimonianze raccolte senza le cautele descritte ai punti 3, 4, 5, non può che innescarsi una catena di reazioni negative.
- Un’altra cautela da osservare per riconoscere l’errore, evitando di maneggiare la storia in modo irresponsabile, è chiedersi se una storia è plausibile o semplicemente suona plausibile perché si accorda con dicerie, sentiti-dire e stereotipi diffusi. Blochscrive: «Quasi sempre l’errore è orientato in anticipo. Soprattutto esso si diffonde e prende radici solo se si accorda con le convinzioni preconcette dell’opinione comune; diventa allora come lo specchio in cui la conoscenza collettiva contempla i propri lineamenti». E aggiunge: «Perché l’errore di un testimone divenga quello di molti uomini, perché una cattiva osservazione si trasformi in una voce falsa, occorre anche che lo stato della società favorisca questa diffusione».
La destra e il revisionismo politico
Il metodo del “revisionismo politico” utilizzato dalla destra neofascista e dall’anti-antifascismo non fa nulla di ciò che Marc Bloch raccomanda: esso si basa sulla menzogna pura e semplice, sul falso, sul richiamo a una documentazione di pura fantasia. Qualsiasi testimonianza, qualsiasi documento partigiano, nazista o fascista anteriore alla Liberazione, o qualsiasi documento successivo americano o inglese, risultato delle indagini alleate sugli episodi più efferati, tragici e deprecabili del periodo ’43-’45, è dichiarato falso, o manipolato, oppure è ignorato. Per il c.d. “revisionismo politico”, insomma, tutto ciò che può documentare la storia drammatica della persecuzione politica e/o razziale, segnarne l’evoluzione, fornire termini politici di paragone è minimizzato, falsificato o ignorato.
Ma, mentre la manipolazione della documentazione dell’eliminazione degli ebrei, la categoria di cittadini più perseguitata nell’Europa occupata dai nazisti, è avvenuta nel corso della Storia stessa, la manipolazione della storia della guerra di Liberazione, che pure non manca, avviene abbondantemente dopo i fatti e, in genere, per una precisa scelta politica; spesso per cause geopolitiche internazionali. Benché sia facile da smascherare perché il fascismo, fortunatamente, fu incapace di immaginare il futuro per ipotecarlo, la manipolazione, quando c’è, risulta evidente alla semplice prova scientifica dello studio delle fonti. Per gli studiosi, ricostruire cosa è stato il totalitarismo fascista può essere talvolta problematico perché l’ampia documentazione è sparsa in diversi archivi, molti dei quali stranieri. Ma, il compito non è impossibile: per consultare i documenti, basta armarsi di pazienza, non porsi limiti di tempo, essere pronti a programmare viaggi nelle città in cui ci sono gli archivi che custodiscono i documenti che interessano lo storico; e, come è intuitivo, bisogna disporre di risorse economiche adeguate. Per inciso, va precisato che, quella che noi, oggi, ricordiamo come Guerra di Liberazione8 dall’occupazione nazifascista, per i fascisti repubblichini era una guerra civile: identificando la patria e lo Stato con il partito, essi consideravano traditori tutti coloro che del fascismo non ne volevano più sapere, cioè la stragrande maggioranza degli italiani.
Benché abbia radici più lontane, la recente manipolazione delle fonti è prevalentemente imputabile al desiderio della destra neofascista e degli anti-antifascisti di proporre la c.d. «faccia buona del fascismo» per cancellare il paradigma antifascista e sostituirlo con quello nuovo dell’anticomunismo, secondo il quale tutta la Resistenza è stata comunista. Siamo di fronte a una smisurata mistificazione che ha profondamente segnato la nostra società e ha contribuito a falsare il quadro della realtà storica nella quale la maggioranza dei ricercatori si sono trovati a lavorare, sin dalla fine della seconda guerra mondiale9.
Il più recente tentativo di alterazione delle fonti ha le sue origini nel gennaio 1995, quando il centrodestra legittimò Alleanza Nazionale, dopo il congresso del Movimento Sociale Italiano di Fiuggi, noto come “il congresso della svolta” e, con l’autorevole avallo berlusconiano, garantì l’ingresso di quel partito nel sistema democratico. Da allora, la divulgazione della Storia della Guerra di Liberazione ha abbandonato ogni rigore scientifico, assumendo un carattere tendenzioso e settario. Ma, se durante la Guerra di Liberazione, combattere con la forza delle armi un Pietro Koch10, il crudele torturatore della «Villa Triste» di Milano, era un obbligo morale, oggi di fronte a un Pansa11, a un Pisanò o ad altri noti e meno noti «assassini della memoria», bisogna rispondere con il metodo scientifico della ricerca storica, decostruendo le loro affermazioni, analizzandole pezzo per pezzo, mettendole a confronto con la documentazione, incrociando documenti e fonti, facendo insomma un’analisi critica, scientifica, puntuale e documentata di ciò che scrivono.
In questo modo, insegna Pierre Vidal-Naquet, lo studioso serio non si metterà sul loro stesso piano, ma smonterà i meccanismi delle loro fandonie e delle loro falsità, rendendo un servizio culturale utile non solo per il presente, ma anche per le nuove generazioni.
Il diritto alla verità
Gli «assassini della memoria» violano sempre, in modo più o meno palese, il diritto alla verità che spetta prima di tutto alle vittime, per evidenti ragioni, e poi alla società intera, che ha diritto di formarsi un’opinione corretta e non eterodiretta da un qualunque pregiudizio12, e, nel caso particolare, da quello anti-antifascista. Va poi detto che negano l’umana misericordia a chi porta il peso insopportabile dell’immenso dolore di queste tristi vicende; nel caso in studio, le famiglie dei quindici partigiani fucilati e le famiglie delle vittime dell’attentato di viale Abruzzi. Insomma, se non c’è alcun dubbio che queste persone abbiano diritto alla verità: chi si propone di trattare la strage di piazzale Loreto, quindi, – sia egli storico o no – dovrebbe sentire il dovere della ricerca della verità nella sua narrazione.
Il diritto alla verità discende dal principio giuridico universale per cui un crimine non è commesso soltanto contro la vittima, ma anche e soprattutto contro la comunità di cui viene violata la legge. Ne consegue che la società si difende dai crimini con leggi adeguate che prevedono sanzioni proporzionali al reato commesso. La società, come e ben più della vittima, deve essere risarcita con la sanzione del criminale per la violazione della legge che garantisce l’ordine pubblico generale. Il diritto alla verità è parte integrante della riparazione13 e la pubblicità della sentenza serve appunto anche a questo.
Tanto per esemplificare, la società ha ritenuto giusto sanzionare Brega Massone, il chirurgo responsabile di aver operato gli inoperabili per un miserabile calcolo economico, comminandogli ventun anni di galera ed espellendolo dall’ordine dei medici, per metterlo in condizione di non nuocere nuovamente alla comunità. Ed è difficile non essere d’accordo.
Perché, dunque, la società non dovrebbe difendersi dal regime criminale che ha portato il Paese alla catastrofe, che ha privato della libertà i suoi cittadini, li ha danneggiati con lutti e rovine infiniti, e li ha gravemente impoveriti? Questa è la ratio per cui la società sanziona il fascismo in Costituzione col divieto di ricostituire quel partito in ogni sua forma, e con leggi14 che ne vietano anche ogni manifestazione formale e di pensiero.
Al di là di ogni considerazione di filosofia del diritto e delle violazioni di legge, non pare inutile ricordare che il diritto alla verità sia stato palesemente violato con l’occultamento della strage di piazzale Loreto nel c.d. «armadio della vergogna», insieme alle altre 694 stragi di cui si compone quel maledetto archivio. Negli oltre cinquant’anni dell’occultamento, come vedremo, la destra fascista doc, neo e post, ha potuto costruire una consistente speculazione politica, ripresa puntualmente da certi organi di stampa.
Per inciso, poi, vale la pena di rilevare che l’equazione antifascismo uguale comunismo, cui spesso ricorrono gli «assassini della memoria» nostrani, è lo strumento con cui si vorrebbe sostituire il paradigma antifascista con il paradigma anticomunista in questa smemorata società che vive in un eterno presente, ignora il suo passato15 e perciò è incapace di progettare il suo avvenire. In realtà, antifascismo è sinonimo di democrazia e di libertà; esso si contrappone al totalitarismo fascista che invece nega l’esercizio di quei diritti civili, fondamentali in una società moderna, e il Parlamento che è ne l’espressione più importante.
Insomma, malgrado gli approfonditi studi storici, a tutt’oggi, c’è chi ancora non ha capito che il fascismo non è il contrario del comunismo16, ma è il contrario della libertà e della democrazia. O, forse, preferisce far finta di non capire.
GLI «ASSASSINI DELLA MEMORIA» DELLA STRAGE DI PIAZZALE LORETO
Nella nostra analisi, vengono presi in esame scritti di giornalisti e intellettuali, alcuni dei quali notissimi, che si sono improvvisati storici, e una persona di parte, l’ex federale di Milano Vincenzo Costa, che ha scritto le sue memorie. Tutti hanno in comune l’assoluta mancanza di trasparenza delle fonti e dei documenti che permettano di rifare il percorso della loro narrazione, al fine di validarla. Ne consegue che la mancata condivisione delle fonti e della documentazione su cui quei racconti si reggono, che è la base della scientificità della storia, ne impedisce la verifica e la validazione. Qui si evidenzia la differenza tra lo storico e il giornalista, l’intellettuale o il memorialista. Lo storico mette a disposizione della comunità scientifica il suo lavoro e la documentazione consultata, per sottoporli alla prova della validazione/falsificazione, sapendo bene, come abbiamo già visto, che in futuro la disponibilità di nuovi documenti potrà mettere in dubbio, o, perfino, modificare totalmente o parzialmente la sua interpretazione. Il giornalista, abituato dalla professione a difendere la segretezza delle sue fonti, di cui è giustamente geloso, quando veste i panni dello storico, mantiene questo suo abito professionale; ma, in questo modo, impedisce di mettere l’intero suo lavoro a disposizione della comunità scientifica, sottraendolo alla prova della verifica/falsificazione. La ricostruzione di fatti storici, realizzata a distanza di tempo dal giornalista che, in buona fede, si comporta in tal modo, non aggiunge alcun contributo valoriale né scientifico alla ricerca storica. Essa può essere invece, considerata un documento, ma solo in quanto cronaca di un evento storico, cioè quando è articolo giornalistico del fatto appena accaduto. Se, all’opposto, c’è malafede, e si pretende di negare o di banalizzare il totalitarismo fascista, talvolta anche irridendo le vittime, o non tenendone minimamente conto, allora ci troviamo di fronte a un «assassino della memoria».
Queste considerazioni valgono anche per l’intellettuale che si improvvisi storico o che, pur essendolo, non corredi il suo lavoro di una sufficiente documentazione o non la preveda proprio. Non posso che condividere quanto scrive Mario Isnenghi dei giornalisti che si improvvisano storici:
«L’autocandidatura di giornali e giornalisti a rappresentarsi come i veri storici – lasciando gli accademici intra moenia ai loro innocui giochetti eruditi – non ha fatto che rinforzarsi e trovare sempre maggiore udienza editoriale… e le pagine di “Cultura e spettacolo” … si sono sempre più affermate come il luogo effettivo del ripensamento storico capace di orientare e riorientare l’opinione pubblica e di far pensare al paese sé stesso, la propria storia»17.
Il memorialista, a differenza del giornalista, non si pone neppure il problema della veridicità del racconto: il suo scopo non è informare, ma proporre al lettore il suo punto di vista. Il suo lavoro può essere più facilmente assimilato al documento; e, naturalmente, il giudizio sul suo valore e come inserirlo nella gerarchia delle fonti, resta un problema professionale dello storico, che lo valuterà nelle modalità e nei termini suggeriti da Marc Bloch.
Per dare un seguito concreto alle nostre considerazioni, proponiamo di seguito la decostruzione e l’analisi critica dei lavori di alcuni «assassini della memoria» della strage di piazzale Loreto. Lo studio spazia dagli autori più noti a quelli meno noti, dai contenuti poco o, talvolta, per nulla veritieri; e da un valore letterario, a volte degno di nota, a quello, più spesso, semplicemente giornalistico.
Vincenzo Costa. Il padre di tutte le menzogne
Volontario negli alpini nella grande guerra, durante la quale divenne grande amico di Aldo Rèsega, fu fascista della prima ora e sansepolcrista; partecipò attivamente all’assalto della sede dell’Avanti! Durante l’esperienza fiumana, fece da collegamento tra Gabriele D’Annunzio e Benito Mussolini18. Alla fine del ’22, lasciò l’esercito e trovò lavoro nelle Officine Meccaniche (OM) di Milano, ove rimase per 17 anni, occupandosi nel frattempo di sindacalismo fascista, assistenza sociale e iniziative sportive, nella zona di Rogoredo. Nel ’37, divenne ispettore dell’Ente Comunale di Assistenza. Nel ’40, fu inquadrato nel 3° Alpini e schierato sul fronte francese; successivamente, prese parte alla spedizione di Russia, rientrando in patria nel gennaio ’43, per un principio di congelamento a un piede.
Dopo l’8 settembre 1943, aderì alla Repubblica sociale italiana, fu nominato vice-federale del Partito Fascista Repubblichino di Milano e, per volontà di Mussolini, comandante della 4ª Brigata Nera Mobile “Aldo Résega”. Federale di Milano dall’aprile 1944 alla Liberazione, fu poi imprigionato nel campo di concentramento di Coltano, presso Pisa, allestito al termine del secondo conflitto mondiale dagli Alleati. Quel campo fu poi utilizzato, fino al settembre 1945, per la detenzione di prigionieri di guerra fascisti, ex RSI, militari germanici e collaborazionisti dell’esercito tedesco di altre nazionalità.
Il 2 aprile 1946, la Corte d’Assise Straordinaria di Milano condannò Costa a 18 anni di reclusione per collaborazionismo, durante i quali iniziò a dedicarsi alla stesura delle sue memorie. Liberato nell’ottobre ’49, le terminerà verso i primi anni ’60; saranno pubblicate nel 199719, a oltre venti anni dalla sua morte.
Analisi de «L’ultimo federale»
Alla pagina 105, in data 9 agosto [1944], Costa scrive:
«Questo è stato il giorno più terribile per Milano. i bombardamenti angloamericani erano stati sino ad allora feroci ed avevano distrutto 15 mila case, innumerevoli opifici e ucciso migliaia di persone: ma nulla è stato paragonabile a questo eccidio destinato a segnare il principio di una lunga catena di sangue e di dolore, un momento indelebile nella storia della città, un episodio in cui solo Satana risultò vincitore. Piazzale Loreto è per gli italiani e gli stranieri la piazza più tragica d’Italia».
Vale qui la pena di mettere in evidenza che Costa, come la quasi totalità dei memorialisti fascisti, dimentica di dire che quando si dichiara una guerra è logico e normale che il nemico si difenda e, presto o tardi, passi, magari, anche all’offensiva. In questa fase, l’Italia fascista, che ha dichiarato guerra a Inghilterra e Francia prima, e a Stati Uniti e mezzo mondo poi, la guerra la sta perdendo. Dopo l’invasione della Sicilia, gli Alleati sbarcano in Calabria e proseguono l’offensiva per mettere a segno il loro piano strategico, semplice da dichiarare, più difficile da attuare: battere l’Italia fascista, risalire la penisola, e costringere Hitler a sguarnire il fronte russo, per soccorrere l’alleato italiano, alleggerendo così la pressione nazista sull’URSS. Quasi contestualmente, con lo sbarco in Normandia, a ovest e la pressione dell’armata sovietica, a est, il piano strategico si completava, chiudendo la Germania nazista in una ferrea e vincente manovra a tenaglia, che, per di più, come effetto secondario, sottraeva il contributo delle industrie italiane alla produzione bellica nazista. I bombardamenti delle città italiane fanno parte del piano e vanno considerati, oltre che obiettivi militari (fabbriche di prodotti bellici, caserme, aeroporti, impianti strategici civili e militari, ecc.), anche un elemento di pressione psicologica sulla popolazione civile per accelerare la resa. Da notare che l’atteggiamento degli Alleati fu molto diverso in Francia, ove, al contrario, si pose cura di evitare, per quanto possibile, il bombardamento dei centri abitati per limitare al massimo la morte di civili20. In questo caso, essendo la Francia parte della coalizione alleata, il bombardamento non voleva essere un elemento di pressione psicologica, ma rappresentava soltanto una necessità strategica e tattica. Ciò che, subito dopo, Costa afferma è particolarmente interessante21.
«Il comando tedesco stava cercando con ogni mezzo di accattivarsi la simpatia della popolazione milanese. Le brutalità, le deportazioni, gli arresti di massa operati nei giorni immediatamente successivi all’8 settembre avevano suscitato paura e odio. Ora però […] che il governo fascista riprendeva con autorevolezza le sue funzioni, i tedeschi obbedivano a un nuovo indirizzo della loro propaganda e soprattutto al console generale di Germania che […] favoriva gesti auspicanti il ripristino del cameratismo e della comprensione. Concerti, spettacoli, ricevimenti, conferenze facevano parte di quell’inizio di cambiamento di atteggiamento verso gli italiani. Il rilascio di alcune centinaia di operai arrestati e destinati al lavoro obbligatorio in Germania, ottenuto dalle SS grazie all’intervento e alle pressioni di Parini, così antitedesco com’era, era stato un gesto emblematico di questa nuova atmosfera di comprensione. Si apriva un periodo in cui la brutalità e le rappresaglie tedesche erano finite, ma sarebbe bastato un solo atto criminoso contro le forze armate tedesche per vederli nuovamente reagire con ferocia.»
Quando mai, in una guerra di conquista, l’esercito che occupa il territorio nemico si preoccupa «di accattivarsi la simpatia della popolazione»? Nell’Est Europa, l’esercito nazista non si è mai preoccupato di essere accettato dalle popolazioni dei territori occupati né ha mai pensato di fare operazioni di pubbliche relazioni. Anzi, le innumerevoli stragi e la brutalità dell’occupazione parlano da sole e, ovunque, Italia settentrionale compresa, qualificano l’azione militare tedesca come determinata e criminale.
In ogni caso, l’incauta affermazione non trova alcun riscontro nelle testimonianze dei cittadini, né nei documenti d’archivio e neppure sulla stampa di regime. Lo stesso Saevecke, comandante della Sipo-SD per Milano e mezza Lombardia, in un rapporto a Berlino sulla strage di piazzale Loreto, non fa alcuna menzione di questa azione di pubbliche relazioni, evidentemente inventata da Costa22. Neppure il Corriere della Sera, organo di stampa allora strettamente controllato dal Partito Fascista Repubblichino (PFR), nei venti mesi di occupazione nazista, spende mai una sola parola per illustrare un programma di quel genere. L’11 agosto 1944, nella pagina del Corriere Milanese, il giornale pubblica un intero articolo che riprende di peso il testo del comunicato della sicurezza nazista per illustrare l’eccidio di piazzale Loreto; ma non fa alcun accenno al preteso programma tedesco di pubbliche relazioni, perché nel comunicato non c’è proprio! Bisogna inoltre evidenziare che il controllo nazista sull’Italia occupata è strettissimo. Già il 10 settembre ’43, quando mise sotto controllo diretto dello stato nazista le due regioni Alpen Vorland23 e Adriatische Kustenland, Hitler aveva deciso di dividere in due il territorio italiano: da una parte, la zona del fronte era sotto il ferreo controllo militare del maresciallo Rommel; nel resto dell’Italia, la zona nota come «territorio occupato» era posta sotto il controllo del plenipotenziario militare tedesco, generale Rudolf Toussaint. Al nord era installato il comando delle SS, con delega totale sulla sicurezza militare della zona. Tutte le relazioni politiche, infine, erano di stretta competenza del plenipotenziario del Reich, Rudolf Rahn. il 13 settembre, Speer ebbe carta bianca per salvaguardare le industrie italiane e dirottare la produzione bellica italiana verso la Germania24. con queste decisioni, prese all’insaputa di Mussolini, Hitler faceva dell’Italia uno stato satellite, simile alla Francia di Vichy. d’altra parte, Mussolini stesso, in una lettera a Claretta Petacci, riconosce la sua condizione di sudditanza rispetto alla Germania nazista:
«La mia è un’opera limitata di carattere amministrativo. Io sono una specie di podestà di un grande comune con poteri nettamente circoscritti. Uno Stato senz’armi è una parodia. Il Papa è infinitamente più armato di me. La Guardia Palatina – secondo i giornali – pur essendo il rifugio di tutta la nobilaglia imboscata – dispone di armi e artiglierie leggere. Io non ho niente, non ho ancora niente. Dopo quattro mesi le truppe giureranno senz’armi. […] Sì, io sono il “cadavere vivente” 25. È una maledizione!»
In una lettera di poco successiva, sempre indirizzata all’amante, Mussolini è ancora più esplicito:
«Io conto meno del due di coppe. Chi governa l’Italia non sono io. Io faccio da ”paravento”, come qualcuno ha detto a villa Feltrinelli] Il popolo mi disistima e mi odia. Dopo un mese, non sono riuscito a portare un solo soldato a Roma.26».
Non è un caso che lo storico tedesco Lutz Klinkhammer, con efficace immagine, definisca l’Italia del 1943-45 l’«alleato occupato». Secondo lo storico tedesco,
«…la brutalità della “lotta contro le bande” non aveva nessuna connessione con il pericolo rappresentato dai partigiani. Perlopiù non si trattava di una risposta a una reale minaccia, quanto piuttosto di “azioni punitive”»27.
Nei venti mesi dell’occupazione nazista in Italia, ovunque, ci sono state tre fasi: la prima, che ha inizio con la presa del potere, in cui si organizza la burocrazia d’occupazione; la seconda fase è quella del carattere amministrativo dell’occupazione, in cui, salvo la fascia del fronte, il potere tedesco viene gestito dall’amministrazione militare che esercita uno stretto controllo dell’amministrazione civile italiana, che meramente esegue le direttive naziste; la terza fase, infine, fu quella del progressivo disimpegno militare, compreso tra l’avvicinamento del fronte per l’offensiva alleata e la ritirata tedesca.
Le stragi avvennero quasi sempre fin dalla prima fase, quando entrarono in vigore gli ordini generali per la repressione del movimento partigiano, già sperimentati con successo nella guerra di sterminio dell’est europa. la disposizione più importante fu la «direttiva di combattimento per la lotta contro le bande nell’est», spesso indicata semplicemente come merkblatt 69/1, che contemplava espressamente l’uccisione di civili, fossero essi ragazzi, donne, bambini o vecchi. essa entrò in vigore in italia nel novembre ’43, nell’ambito della 14a armata, ma molto probabilmente anche la 10a armata l’adottò, fin dall’8 settembre28.
I recenti studi per realizzare l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia29 addebitano alla direttiva merkblatt 69/1 il comportamento criminale di molti reparti tedeschi – e non solo delle SS – che complessivamente fece oltre 25 mila vittime civili.
Altro che «concerti, spettacoli, ricevimenti, conferenze»!
Ma proseguiamo pure con quanto dice Costa dell’attentato di viale Abruzzi dell’8 agosto ’44.
«Alle 7 di ogni mattina, sotto gli alberi di viale Lombardia, angolo piazzale Loreto, giungeva una decina di camion tedeschi dai quali venivano calate ceste ricolme di verdura, di patate, di frutta che la Staffen [sic]-propaganda acquistava al mercato di Porta Vittoria e distribuiva gratuitamente ai cittadini. Il mattino del 9 agosto si snodava sotto gli alberi una lunga fila di massaie in attesa del loro turno».
Chiunque conosca la toponomastica di Milano sa che viale Lombardia nasce in piazza Piola e finisce in piazza Durante, a oltre 700 metri da piazzale Loreto!
Una decina di camion tedeschi che tutte le mattine scaricava ceste ricolme di verdura, patate e frutta? Come mai una colonna militare di quelle dimensioni non ha un preciso ordine di servizio di cui, se c’è, si possa cercare traccia? E come mai non ce n’è traccia alcuna nel famoso comunicato della sicurezza nazista?
«Acquistate al mercato di Porta Vittoria»? Ma i nazisti, che occupano militarmente il Nord e il Centro Italia, non hanno bisogno di “acquistare”, confiscano e basta! Tutt’al più – ma accade raramente – rilasciano un pezzo di carta per giustificare la requisizione.
Il «9 agosto»? L’attentato avviene in viale Abruzzi, l’8 agosto ’44, alle 8.15, all’altezza del numero civico 7730, che ancora oggi, sul muro, porta i segni delle schegge, ed è a circa 700 metri da piazzale Loreto.
Ma andiamo pure avanti.
«Un grosso maresciallo tedesco, grande come la statua di san carlo d’arona, dalla faccia di bonaccione bevitore di birra, sorridente con tutti, prendeva la merce e la calava nelle capaci borse. le donne ringraziavano e se ne andavano veloci. […] nottetempo, nelle casse ricolme «ignoti» posero una bomba ad orologeria e quando al mattino il solito maresciallo, “el carlun”, come lo chiamavano le massaie, era affaccendato a distribuire verdure l’infernale ordigno scoppiò con un tremendo schianto: i morti furono sette, cinque soldati tedeschi, compreso il grosso maresciallo, e due popolane milanesi; i feriti più o meno gravi furono una trentina».
Bel quadretto di costume! Peccato che sia falso: è tutt’un’invenzione di Costa. Confrontandolo col è avvenuta il mattino del 10 – 8 – 1944 in Piazzale Loreto».
L’intero paragrafo dimostra, in modo del tutto involontario, il ruolo subalterno della RSI: chi prende le decisioni è il comando della sicurezza nazista, che decide la “rappresaglia”, emana il comunicato della fucilazione, ne ordina la pubblicazione al Corriere della Sera, che lo pubblica quasi integralmente, e pretende dai fascisti il plotone d’esecuzione e il servizio d’ordine.
«… il comandante Colombo avrebbe dato un plotone di volontari della Muti e della guardia nazionale, mentre da parte mia avrei fornito due compagnie di fucilieri della brigata nera Resega a disposizione del questore Bettini per il servizio d’ordine pubblico e per bloccare gli accessi a piazzale Loreto dove sarebbe avvenuta l’esecuzione».
Il comandante della Muti e il federale, comandante anche la brigata nera Aldo Résega, eseguono gli ordini nazisti senza battere ciglio.
E, più avanti Costa scrive:
«Alle 7 del 10 agosto, 10 cittadini italiani furono fucilati per rappresaglia a piazzale Loreto: 7 erano stati uccisi il 9 mattina, 10 il giorno successivo: 17 vittime, alle quali si aggiunsero quelle del 28 aprile 1945. Il comando tedesco impose che i fucilati restassero esposti per due giorni sul posto dell’esecuzione».
Dieci italiani? Dovevano essere venti: come mai sono stati dimezzati? È forse intervenuta la c.d. mediazione del fascismo repubblichino? Se è così, perché Costa perde l’occasione di metterla in evidenza ancora una volta?
Comunque sia, Costa continua la sua personale saga degli errori: i fucilati sono 15 e non 10; mette insieme due episodi diversi (l’attentato dell’8 [che per lui è il 9] e la strage del 10 agosto) e, confonde le idee al lettore, aggiungendo per soprammercato l’esibizione dei corpi del 28 [recte, 29] aprile 1945.
Per quanto concerne l’esibizione dei morti partigiani, nella documentazione attualmente nota, non c’è traccia di un ordine di abbandonare i cadaveri sul selciato del piazzale per due giorni, per ammonire la popolazione. Anzi: la documentazione a oggi disponibile ci consente di dire che lo scempio dell’esposizione dei poveri morti durò un solo giorno né ci fu un ordine nazista che l’ordinò per due giorni34. Tuttavia, è certo che la tragica scena non si protrasse oltre le ore 20, perché di questo esistono documentazione e testimonianze. Il cardinale Schuster, già informato dal diacono Giovanni Barbareschi che, in mattinata aveva benedetto i poveri corpi per suo ordine, nel tardo pomeriggio fu aggiornato della situazione anche dal prefetto Parini, e inviò una vibrata protesta all’Ambasciata tedesca, minacciando che, se i cadaveri non fossero stati rimossi immediatamente, l’avrebbe fatto lui personalmente35.
L’introduzione di Giuseppe Parlato
Come abbiamo già visto, nell’aprile 1946, condannato dalla Corte d’Assise Straordinaria di Milano per collaborazionismo, Costa inizia a dedicarsi alla stesura delle sue memorie, nel carcere di Pizzighettone. Liberato nell’ottobre ’49, le correggerà, ampliandole con notizie apprese dopo, corredandole di rari commenti critici, e terminandole, infine, verso la metà degli anni ’60.
Negli anni ’90, i suoi eredi riescono a interessare al volume Renzo De Felice che non espresse un giudizio valoriale sui contenuti ma sul valore documentale delle memorie. Preso da mille impegni, non intervenne personalmente nella cura del volume di Vincenzo Costa, ma segnalò alla famiglia Costa un suo allievo molto preparato, Giuseppe Parlato, che del volume di memorie di Vicenzo Costa, “L’ultimo federale”, fu poi curatore.
Parlato apprezza il taglio memorialistico che trova concreto e asciutto, senza particolari concessioni alla retorica di regime. Si trova però di fronte a un’opera ponderosa, che abbraccia le vicende personali di Costa, calate nella storia del fascismo primigenio per arrivare fino al fascismo repubblichino della RSI, nel 1943-1945 e oltre, fino al dopoguerra. Parlato ne estrarrà il periodo in cui Costa è il federale di Milano, perché, giustamente, considera la federazione milanese un osservatorio privilegiato di un tempo tragico e particolarmente travagliato per l’intero Paese.
Non casualmente, molti storici e giornalisti di ogni tendenza, a partire da Giorgio Pisanò per arrivare fino a Giorgio Bocca, hanno mostrato interesse per quelle pagine, a cui molti hanno attinto, citandone brani interi, per ricostruire aspetti importanti del fascismo repubblichino o, più semplicemente, per illustrarne alcuni momenti particolari36.
Ciò che a noi interessa in modo molto particolare, è la nota 18 della pagina XVII dell’Introduzione di Parlato perché lì si parla testualmente del
«… largo uso che Pisanò fece per la sua Storia della guerra civile in Italia 1943-1945 (Milano, 1974, pp 190 ss., 922 ss., 960 ss., 1510 ss.) delle memorie di Costa, dategli in visione direttamente dall’autore e utilizzate con il suo consenso».
La prima edizione del libro di Pisanò è del 1964. L’informazione è importante perché le pagine 922 e seguenti, più esattamente quelle da pagina 926 a pagina 928, sono quelle in cui Pisanò parla della strage di piazzale Loreto, che analizzeremo nelle prossime pagine. Ed è proprio a queste che si ispireranno poi altri «assassini della memoria», dai più importanti a quelli di mezza tacca per narrare di quell’eccidio. In conclusione, le memorie di Vincenzo Costa rappresentano la matrice di tutte le successive narrazioni della strage di piazzale Loreto, utilizzate dalla destra neofascista.
Giorgio Pisanò. L’arcifascista
Giorgio Pisanò, giornalista, nacque a Ferrara nel 1924, da una famiglia meridionale, della piccola borghesia dell’impiego statale. Poco dopo l’armistizio dell’8 settembre, si arruolò volontario nella X Mas e fu assegnato alla raccolta di informazioni oltre le linee nemiche. Nel 1944 fu paracadutato nei pressi di Roma oltre le linee anglo-americane. Preso prigioniero dall’esercito inglese mentre tentava di ripassare le linee, non identificato come agente fascista, fu imprigionato per un mese nel carcere di Arezzo, perché sorpreso a circolare in zona di guerra senza permesso. Rientrato fortunosamente nel Nord Italia, il 20 aprile 1945, raggiunse la Valtellina dove si stava organizzando il c.d. ridotto alpino. Preso prigioniero dai partigiani il 28 aprile 1945, fu incarcerato a Sondrio, e poi trasferito nel carcere milanese di San Vittore, ove restò fino al 26 ottobre 1945. Successivamente, fu ristretto nei campi di concentramento alleati di Terni, prima e di Rimini, poi, da cui fu liberato nel novembre 1946.
Nel 1948, Pisanò cominciò la sua attività di giornalista nel Meridiano d’Italia, un settimanale di destra neofascista, iniziando anche a condurre ricerche per provare gli omicidi compiuti dai partigiani nel dopoguerra. Divenuto giornalista professionista, nel 1954, approda a Oggi, settimanale fondato da Angelo Rizzoli e diretto da Edilio Rusconi. Nel 1960, Rusconi che, lasciato Oggi per diventare editore di Gente, lo chiama al suo settimanale e lo incarica di raccogliere materiale fotografico e documentale sulla Resistenza, per un reportage da pubblicare a puntate.
Nel 1963, Pisanò si mette in proprio, a sua volta, con il settimanale Secolo XX. È di quegli anni l’attività storico-saggistica: pubblica diversi volumi sulla seconda guerra mondiale e sul fascismo durante la RSI. Nel 1968, ridà vita al settimanale Candido, erede di quello fondato da Giovannino Guareschi, assumendo la carica di direttore, che manterrà fino al 1992.
Nel 1972, venne eletto senatore per il Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale, nella circoscrizione Lombardia. Fu riconfermato ininterrottamente per cinque legislature fino al 1992. Nel 1995, dopo la svolta di Fiuggi, abbandonò Alleanza Nazionale, e, con Pino Rauti, fondò Fiamma Tricolore, per dare continuità agli ideali politici del fascismo storico; ma, qualche mese più tardi, lasciò la vita politica per motivi di salute. Morì a Milano il 17 ottobre 1997.
Analisi della «Storia della guerra civile in Italia
Nella narrazione di seconda mano dell’attentato di viale Abruzzi, Pisanò riprende, dalle memorie di Costa37, l’episodio della distribuzione di generi alimentari alla popolazione da parte dei nazisti, inserito nel quadro di un inverosimile programma nazista di pubbliche relazioni, e conferma l’errore di datazione. Corregge invece la collocazione topografica dell’episodio, che Costa, erroneamente, pose «sotto gli alberi di viale Lombardia, angolo piazzale Loreto» ed elimina la «decina di camion tedeschi» che, opportunamente, Pisanò riduce ad uno solo (senza tuttavia accennare al rimorchio, citato invece nel rapporto del capitano Formosa ) mentre è una decina il numero di militari che aiutano el Carlun, il corpulento quanto immaginario maresciallo tedesco.
Il risultato del lifting di Pisanò è il seguente testo:
«Ma l’episodio che doveva scatenare la terribile rappresaglia di piazzale Loreto38 accade la mattina del 9 agosto39 in viale Abruzzi. Già da alcune settimane, i “gappisti” avevano notato che, ogni mattina, alcuni camion dell’esercito tedesco si fermavano in viale Abruzzi, poco lontano da piazzale Loreto40, e distribuivano gratuitamente alla popolazione ceste di verdura, frutta, pane, frattaglie e così via, residuo evidentemente delle loro mense. La distribuzione veniva effettuata da una decina di soldati germanici al comando di un maresciallo41 grande e grosso, bonario e gioviale, che gli abitanti della zona avevano finito con soprannominare, el Carlün (il Carlone)».
Residuo delle mense naziste? La fantasiosa aggiunta di Pisanò è davvero una sciocchezza: in tempo di guerra, i generi alimentari erano razionati, la gente per nutrirsi faceva ricorso alla borsa nera, sotto gli occhi delle autorità che avrebbero dovuto controllare, senza che queste facessero una piega; anzi, spesso, erano complici dell’illecito commercio. Per rendersi conto dell’assurdità dell’affermazione, basta guardare la fotografia del denutrito mutino posto a guardia delle vittime della strage: sia i militari italiani che quelli tedeschi, per nutrirsi ricorrevano alle requisizioni nelle campagne; e, spesso, le spedizioni per l’approvvigionamento alimentare erano destinate all’insuccesso. Altro che «residuo evidente delle mense» naziste!
«I comunisti non tardarono a comprendere che questa distribuzione quotidiana stava creando dei vincoli di simpatia nella zona Loreto tra i tedeschi e la cittadinanza. Decisero allora di interrompere questi rapporti e di interromperli nella maniera più sanguinosa possibile».
Conclusione soggettiva di Pisanò, che non è suffragata da alcuna documentazione, ma fa il paio con le affermazioni di Costa sulla presunta tregua, non si sa da chi dichiarata.
«La mattina del 9 agosto, allorché i camion germanici giunsero in viale Abruzzi, i “gappisti”, confusi tra la folla, riuscirono a collocare destramente in alcune ceste, già posate a terra accanto ai camion, delle bombe ad alto potenziale e si allontanarono immediatamente».
Pisanò ha già identificato i colpevoli dell’attentato: sono i “gappisti”; e agiscono con destrezza, lasciando le bombe nelle ceste “già a terra”.
«Pochi minuti dopo una serie di terrificanti esplosioni seminò la strage. Cinque soldati tedeschi e cinque civili restarono fulminati. Tra i tedeschi, anche el Carlün. Ecco i nomi dei civili: Edoardo Zanini, Giuseppe Giudici, Primo Brioschi, Giuseppe Zanicotti e una donna rimasta sconosciuta».
I cinque morti tedeschi sono un’invenzione di Costa che Pisanò trasferisce – pari pari – nel suo racconto e, come Costa, non ne cita i nomi. Come abbiamo già visto nell’analisi della narrazione di Costa, secondo il rapporto del capitano della GNR Formosa, i morti sono sei e sono tutti civili italiani. D’altra parte, non c’è alcun riscontro documentale della pretesa morte di cinque sconosciuti militari tedeschi all’archivio dell’obitorio, né agli archivi dei cimiteri milanesi, o negli ospedali milanesi né altrove42.
L’attentato avviene «intorno alle 8 dell’8 agosto», e nello stesso pomeriggio, la donna sconosciuta sarà identificata dal marito, Rodolfo Vellani, per Amelia Berlesi, di anni 3943. Tra i nomi degli italiani citati da Pisanò, morti nella doppia esplosione (quindi, non una serie), manca il nome di Gianfranco Moro, il sesto morto del rapporto del capitano Formosa, che Pisanò, invece, colloca tra i feriti gravi, deceduti in un secondo momento.
«Altri sedici civili, tra i quali numerose donne e bambini, restarono gravemente feriti: quattro di questi, Gianfranco Moro, Antonio Beltramini, Enrico Masnata, e Antonio Brambilla, morirono nelle ore successive».
Per Pisanò, i morti in seguito alle ferite coincidono con quelli del Corriere della Sera, mentre il numero dei feriti (12) è diverso (per il Corriere sono 13). Fatto interessante: il rapporto del capitano Formosa ne riporta, tra gravi e leggeri, undici. Tra i nomi di morti e feriti, eccetto la donna sconosciuta (Amelia Berlesi), il rapporto fascista non riferisce nomi di donne né di bambini. La generica affermazione è presa di peso dal “Comunicato” del Comandante della Sicurezza tedesca dell’11 agosto. Secondo la documentazione del Civico Obitorio, poi, eccetto Masnata Enrico, nessuno dei nomi indicati da Pisanò è riconducibile all’attentato di viale Abruzzi. Per quanto concerne il Masnata, l’attribuzione è dubbia perché, malgrado che il numero del nulla osta dell’autorità giudiziaria, che autorizza la rimozione della salma, possa essere riconducibile a quello delle altre vittime dell’attentato, il corpo proviene dal Policlinico (e non dall’Ospedale di Niguarda, ove, secondo il rapporto Formosa, sono stati trasferiti tutti i feriti gravi); senza contare che quel nome non compare tra i feriti gravi del rapporto della GNR.
Per dare maggior peso al suo racconto, Pisanò cita il federale Costa, dicendo che quando la notizia dell’attentato di viale Abruzzi giunse tra i fascisti della federazione
«Riuscimmo comunque a impedire che i fascisti si abbandonassero a rappresaglie indiscriminate e contemporaneamente cercammo di sapere che cosa stesse maturando nei comandi germanici».
Pisanò cerca poi di legittimare la c.d. “rappresaglia”, che le autorità naziste hanno in programma, attribuendo alle convenzioni internazionali l’autorizzazione alla fucilazione di dieci italiani per ogni tedesco ucciso, stabilito invece unilateralmente ed arbitrariamente dal c.d. “Bando Kesselring”, che pure viene ricordato.
Decisamente false, invece, sono le affermazioni che tutte le autorità fasciste si adoperarono per impedire che la rappresaglia avesse luogo perché consci
«come eravamo che l’attentato era stato compiuto al solo scopo di provocare la reazione germanica e speculare poi sul sangue degli innocenti che ne sarebbero andati di mezzo.».
Solo una mentalità contorta come quella fascista può pensare una cosa del genere e attribuirla al nemico che, per definizione e senza alcuna capacità di distinguere le diverse appartenenze degli antifascisti, è solo e soltanto comunista. Comunque, la sola autorità fascista che si mosse, accanto al cardinale Schuster, fu il prefetto Parini che tentò inutilmente di mettersi in contatto con le più alte autorità tedesche che si rifiutarono di parlargli44.
«Le autorità italiane ottennero solo di ridurre il numero degli ostaggi da fucilare che infatti venne portato dai cinquanta preventivati a quindici».
I cinquanta ostaggi da fucilare sono un’invenzione di Pisanò per conciliare così, riprendendo il parto della fantasia di Costa, i cinque soldati tedeschi morti nell’attentato di viale Abruzzi con il c.d. bando Kesselring. Il documento del Comandante della Sicurezza nazista (senza data), che annuncia la fucilazione, dice che l’elenco dei fucilandi era di 26, poi ridotti a quindici per autonoma decisione nazista. Dieci furono trattenuti come ostaggi a disposizione dei tedeschi, nel caso che si ripetessero atti terroristici (così nel manifesto di Saevecke). L’unica donna, Giuditta Muzzolon, dice sempre il comunicato della Gestapo, fu graziata. Tutto ciò non corrisponde comunque al vero: la Muzzolon fu avviata al campo di concentramento di Ravensbrück e si salvò per pura fortuna. Anche i dieci “ostaggi” furono avviati ai campi di concentramento: inviati prima a Flossemburg e poi a Dachau, ne torneranno solo la metà, i più giovani e robusti. Tra essi, Eugenio Esposito, figlio di Andrea, uno dei quindici; verrà a sapere della morte del padre solo al suo rientro.
Pisanò cerca qui di accreditare il fascismo repubblichino di iniziative a tutela di vite italiane che, almeno in questo caso, è decisamente falso. Il viceprefetto Bettini, nella sua testimonianza alla Corte d’Assise Straordinaria di Milano del 28 agosto 1946, già ricordata45, e quella dell’Obersturmführer SS Eugen Krause, anch’essa già ricordata46, confermano che dai documenti, appare chiaro che la tutela delle vite italiane non è in cima ai pensieri dei fascisti repubblichini, che invece si mostrano particolarmente zelanti verso i nazisti, a scapito delle vite italiane.
Fin dall’inizio Pisanò imputa ai “comunisti” (per il fascismo repubblichino tutti gli antifascisti sono comunisti; la semplificazione, ripresa da chi utilizza la sua Storia della guerra civile in Italia come fonte, giunge intatta fino ai giorni nostri) il machiavellico piano di commettere l’attentato per provocare la reazione nazifascista e stracciarsi poi le vesti di fronte al popolo milanese, indignato per la ferocia della reazione.
Sono gli stessi argomenti che il fascismo doc, neo e post usa per la strage delle Fosse Ardeatine a Roma, ben più terribile, ma ispirata dagli stessi folli criteri. Il ragionamento rivela di essere generato in un periodo successivo al 1943-45: nella guerra asimmetrica che vede i partigiani combattere contro le truppe di occupazione naziste e fasciste, la rivendicazione degli attentati fa parte della strategia e della tattica; la Resistenza, per mettere in difficoltà gli eserciti regolari contro cui combatte, deve sopperire all’inferiorità numerica e alla povertà di mezzi, ingigantendo gli atti bellici compiuti; infine, la strategia della comunicazione equivale a un’arma molto potente: bisogna far conoscere alla popolazione che c’è la Resistenza che si oppone ai sistemi totalitari fascista e nazista.
La narrazione di Pisanò riveste una particolare importanza perché dimostra che è ripresa dalle memorie di Costa, non ancora pubblicate, mentre la Storia della guerra civile in Italia di Pisanò uscirà tra il 1964 e il 1965. Tutti gli anti-antifascisti o i neofascisti dichiarati che narreranno della strage di piazzale Loreto, utilizzano il volume di Pisanò come fonte e sono chiaramente identificabili perché riportano gli stessi errori, pur cambiando particolari marginali.
Vittorio Messori. Un italiano ben poco serio
Vittorio Messori nacque a Sassuolo, nel 1941; a guerra finita, la famiglia si trasferì a Torino, dove il padre – che non nascose mai il suo anticlericalismo – aveva trovato lavoro presso l’Italgas. Giornalista e scrittore, egli ha collaborato con La Stampa, Avvenire, Corriere della Sera e Jesus, solo per citare le testate più note.
Dopo la maturità classica presso il liceo D’Azeglio, Messori si laureò, nel 1965, alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, con una tesi in storia del Risorgimento (relatore Alessandro Galante Garrone) e con due tesine discusse con Luigi Firpo e Norberto Bobbio.
Nel 1970, entrò a Stampa Sera come redattore della cronaca cittadina. Dopo quattro anni di cronaca, Arrigo Levi, allora direttore del giornale, lo chiamò a far parte del gruppo di tre giornalisti destinati a dar vita a Tuttolibri, il nuovo settimanale culturale del quotidiano torinese.
Nello stesso periodo, Messori consegnò alla SEI il manoscritto del libro Ipotesi su Gesù, inchiesta sulle origini del cristianesimo. L’editore lo pubblicò un anno dopo, nell’autunno del 1976, con una tiratura iniziale inferiore a tremila copie che andarono esaurite in poco tempo, così come le successive ristampe. A oggi, il libro ha venduto ben più di due milioni di copie in tutto il mondo.
Nel 1984 intervistò il cardinale Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ne risultò un saggio a quattro mani, intitolato Rapporto sulla fede, pubblicato l’anno successivo dalle edizioni San Paolo e poi tradotto in molte lingue. La denuncia dei «pericoli» e delle «difficoltà» della Chiesa e la condanna della teologia della liberazione provocarono le critiche degli ambienti progressisti cattolici.
Nel 1990 Messori diede alle stampe la biografia del beato Francesco Faà di Bruno (titolo Un italiano serio). La presentazione del volume, avvenuta al meeting di Comunione e Liberazione, generò una violenta polemica, per una frase di Messori, in cui invocava un processo di Norimberga per i principali esponenti del Risorgimento.
Nell’ottobre del 1993, in occasione dei quindici anni di pontificato, a Messori fu proposto di intervistare Giovanni Paolo II, prima intervista della storia a un pontefice. Messori espresse al Papa le sue perplessità sull’opportunità dell’operazione: «Santità, abbiamo bisogno di un Papa, di un maestro che ci guidi, non di un opinionista televisivo». Il Papa lo mise a tacere rispondendo semplicemente: «Non sono d’accordo con lei».
Il 24 dicembre 2014, sul Corriere della Sera, Messori ha pubblicato un articolo-confessione dal titolo “I dubbi sulla svolta di Papa Francesco”, nel quale esprime un giudizio molto critico su Papa Francesco, esprimendo le sue perplessità sul nuovo corso stabilito dal Pontefice.
Nella numerosa storiografia della strage nazifascista di piazzale Loreto, si inserisce anche un articolo di Vittorio Messori, raffinato e colto intellettuale cattolico, di chiara fama. Sorprende che il suo non sia un lavoro accurato, rigoroso, ligio alle regole della ricerca scientifica – cui l’autore dovrebbe essere abituato -, ma piuttosto costretto negli angusti limiti del pregiudizio anti-antifascista. Per chi ne conosce le opere, è difficile immaginare Messori nei panni di Torquemada; eppure, la sua narrazione finisce per farne emergere una figura molto simile a quella dell’intransigente inquisitore. D’altra parte, la Storia è scienza in quanto ricerca in divenire continuo e, per questo, falsificabile, cioè dimostrabile falsa e, come ogni principio scientifico, deve essere verificabile e soggetta a smentita47. È lecito, dunque, pensare a uno scivolone di Messori. La sua specchiata fama di storico ci fa pensare che non possa non essere consapevole che i contenuti, così palesemente di parte, erronei e volti a orientare il pensiero dei suoi lettori verso l’area più conservatrice – diciamo così, volendo essere indulgenti – lo espongono irrimediabilmente al rischio del discredito sul piano morale prima ancora che su quello professionale.
In ogni caso, se chi scrive non ha certamente titolo per criticare il suo lavoro di storico del cattolicesimo, è tuttavia in grado di mettere in evidenza le contraddizioni di Messori quando affronta un campo storico che non gli è proprio; soprattutto, perché risulta palese ch’egli, nel suo articolo sulla strage nazifascista di piazzale Loreto, non ha rispettato le rigorose leggi della metodologia della ricerca storica. Anzi, si dimostra prigioniero dei suoi pregiudizi.
Lascio, quindi, ai lettori il compito di verificare la mia affermazione e di giudicare l’azzardato articolo di Messori sulla strage nazifascista di piazzale Loreto.
Analisi dell’articolo «Piazzale Loreto come via Rasella»
La cosa che più sorprende nell’articolo di Messori48, è l’assenza di ogni dubbio e la sua adamantina, incrollabile certezza di possedere “la verità”; a maggior ragione, se consideriamo che il processo al criminale di guerra Theodor Saevecke, all’epoca unico ancora in vita dei diciotto responsabili della strage nazifascista, si è concluso nel giugno 1999, mettendo a disposizione degli studiosi una considerevole mole di documenti sull’argomento49 che però Messori ignora. Malgrado ciò, egli incautamente invoca la tirannia del Grande Fratello orwelliano
«che vuole irreggimentarci e controllarci dalla culla alla tomba, […], dicendoci non soltanto come dobbiamo votare, ma come dobbiamo pensare e vivere»,
perché – afferma – riferendosi alla storiografia del famoso eccidio,
«nessuno dice come andarono davvero le cose».
E aggiunge, temerariamente:
«È solo l’amore per la verità che deve contrassegnare un cristiano che mi spinge a ricordare lo svolgimento dei fatti, non certo una qualche simpatia per il fascismo, per il quale ho la stessa estraneità, anzi orrore, che nutro verso il comunismo50».
Insomma, un invito a verificare la sua versione di «come andarono davvero le cose». E, considerato che ignora gli esiti e la documentazione del processo Saevecke, l’amore della verità ci porta a concludere che Messori “una qualche simpatia per il fascismo” ce l’ha per davvero!
Anche se volessimo tralasciare la captatio benevolentiae della citazione di Pertini, forse il più popolare tra tutti i presidenti della Repubblica, e il veniale errore nell’attribuirgli la definizione di «macelleria messicana»51, per la macabra esposizione dei corpi di Mussolini, della sua amante e dei gerarchi fascisti, in quella piazza, il 29 aprile 1945, Messori comincia davvero molto male. Infatti, dice testualmente:
«In quel nodo di traffico convulso ben più che piazza, un monumento comunque c’è: ed è quello dedicato ai diciassette milanesi fucilati dai tedeschi il 9 e il 10 agosto del 1944».
Ciò che egli scrive è frutto di una lettura superficiale e frettolosa delle memorie di Costa: Messori sommariamente dichiara che i tedeschi (il 9 e il 10 agosto) fucilano “diciassette milanesi”, mettendo insieme l’attentato di viale Abruzzi e la strage nazifascista.
Per rispetto della verità fattuale, è necessario ribadire che i partigiani milanesi, fucilati dai militi della brigata nera Ettore Muti (e non “dai tedeschi”, come dice Messori), all’alba del 10 agosto 1944 (e non “il 9 e il 10 agosto”), per ordine del comando della sicurezza nazista, non furono diciassette ma quindici; ed è infatti a loro che è dedicata la stele in memoria della strage. Bisogna poi aggiungere che non è il fatto in sé, che spiega perché Valerio scelse piazzale Loreto, per rendere pubblica la fine di Mussolini e della dittatura. Ciò che lo indusse a quella scelta, invece, fu lo sprezzante vilipendio dei corpi dei partigiani assassinati lì otto mesi prima dai fascisti, esercitato dai militi di guardia, sommato al feroce, arrogante obbligo imposto ai passanti, armi alla mano, di assistere all’oltraggio dei corpi, inferto dai fascisti dopo la fucilazione. La strage nazifascista di piazzale Loreto e le modalità con cui fu eseguita ebbero indubbiamente un forte valore simbolico per la Resistenza italiana e, soprattutto, milanese. Non avendo indagato a fondo sull’intera vicenda, Messori non lo capisce, ed è per questo che non riesce neppure a capire il nesso causale che lega la strage al secondo e più famoso episodio legato a questo luogo: l’esposizione dei corpi di Mussolini, della sua amante e dei gerarchi fascisti, il 29 aprile 1945. È comprensibile, quindi, che la sua ignoranza gli impedisca di spiegarlo anche ai suoi lettori.
Come “andarono davvero le cose”, si sa invece benissimo: l’ha già accertato il Tribunale Militare di Torino, ben sei anni prima dell’indecente articolo, condannando all’ergastolo il criminale di guerra nazista, Theodor Saevecke; è Messori che non lo sa. Per saperlo, senza andare poi tanto lontano, nel tempo come nello spazio, bastava che egli consultasse l’archivio del Corriere, per cui stava scrivendo l’articolo in questione, che aveva seguito quel processo in ogni sua fase.
Invece, Messori si affida pedestremente alle memorie di Costa:
«Le sue memorie sono state giudicate veritiere e oggettive dal maggior esperto di queste cose, Renzo De Felice, ed egli stesso le ha fatte pubblicare da un’editrice insospettabile come il Mulino, che le ha ripresentate in queste settimane in edizione economica.»
Accecato dal suo pregiudizio anti-antifascista, egli ha mancato di applicare al suo articolo il rigore scientifico del ricercatore e si è affidato alla fama di De Felice, unico storico coinvolto nella valutazione del volume. E il famoso storico del fascismo non espresse un giudizio valoriale sui contenuti; semmai, lo fece sul valore documentale, in quanto memorie di parte. Tuttavia, Messori, non è uno sciocco né un ricercatore improvvisato: dobbiamo, dunque, accreditarlo di un approccio superficiale alla fonte, scartando la malafede? Direi di no. Vien da dire, piuttosto, che il moralismo sta all’etica professionale dello storico come la stupidità sta all’intelligenza.
Vista la miseria morale dell’articolo, poi, Messori avrebbe fatto meglio a non invocare l’etica cristiana per esprimere la sua avversione ai due totalitarismi, perché la superficiale approssimazione della sua narrazione induce i lettori appena un poco documentati a capire immediatamente quanto poco sincera sia la sua dichiarata equidistanza. Tra l’altro, oltre a negare la misericordia cristiana a chi porta il peso insostenibile dell’immenso dolore di questa vicenda (le famiglie dei quindici partigiani assassinati, ma anche le famiglie delle vittime dell’attentato di viale Abruzzi), Messori viola platealmente il diritto alla verità che spetta, non solo e prima di tutto, alle vittime, per ovvie ragioni, ma anche alla società intera, che ha diritto di formarsi un’opinione, rispettosa delle norme del vivere civile, e non eterodiretta dal suo pregiudizio anti-antifascista. Insomma, se non c’è alcun dubbio che i famigliari delle vittime e l’intera società abbiano diritto alla verità, Messori, nella sua narrazione storiografica, ha specularmente il dovere morale, cristiano e professionale di dire la verità. Se, con la stessa intransigenza, applicassimo il rigore del suo integralismo cattolico a quanto egli scrive, dovrebbe bruciare nelle fiamme dell’inferno per l’eternità.
Vale la pena di ribadire, ancora una volta, quanto già affermato in linea di principio: antifascismo non è sinonimo di comunismo, ma di democrazia e di libertà; l’antifascismo si contrappone al totalitarismo fascista che, invece, nega con la violenza, l’esercizio della democrazia rappresentativa e dei diritti civili, principi basilari in una società moderna.
A questo proposito, non c’è alcun bisogno di Messori per sapere che fascismo e comunismo sono due totalitarismi: il fatto è ormai accettato e indubbio, già dagli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Hannah Arendt scrisse le sue riflessioni sul totalitarismo52. Ciò che invece resta inaccettabile è la tendenziosa e pregiudiziale insistenza di Messori nel confondere antifascismo con comunismo. Con ironia del tutto involontaria, mentre egli prende le distanze dal Grande Fratello, riempie il suo articolo di false notizie, utilizzando l’indubbio credito di cui gode presso i suoi lettori, per orientarli verso la sua interpretazione della storia della guerra di Liberazione, e per suggerire loro «come [e cosa] devono pensare» della strage di piazzale Loreto.
A questo punto, sorge legittimo il dubbio che non sia per comodità ma per scelta pregiudiziale che Messori faccia riferimento al ricordo soggettivo di Costa, attribuendogli un avallo di tutti gli storici che non c’è mai stato, e per questo motivo, tra le altre cose, è fuori della metodologia della ricerca storica. Quando egli scrive il suo articolo, il processo a Saevecke si è concluso da quasi sei anni e, da allora, sono disponibili i documenti che hanno stabilito la verità giudiziaria, ma anche l’attuale verità storica, su quel tragico evento e la sua genesi. Eppure, Messori non si prende nemmeno la briga di consultarli: non è neppure a conoscenza che c’è stato un processo, che ha analizzato la strage, studiato le motivazioni e le fonti, vagliato ogni atto, esaminato le responsabilità e le azioni di ogni attore sulla base di documenti e testimonianze inequivocabili, giungendo a conclusioni ben precise che hanno portato la corte militare a esprimere un verdetto di colpevolezza dell’imputato di quella strage, sanzionandolo con l’ergastolo. La documentazione di quel processo è a disposizione del pubblico. Né Messori si pone alcun dubbio sul perché si riparli di quell’eccidio a distanza di oltre cinquant’anni: per lui non esiste l’armadio della vergogna, in cui i vertici dello Stato hanno occultato, per oltre 50 anni, i fascicoli delle stragi naziste e fasciste. O, se lo sa, preferisce non parlarne.
Affermare dunque che la ricostruzione di Costa della strage sia
«confermata da tutti gli storici53, […] in pubblicazioni accademiche, da non far circolare troppo per non suscitare le reazioni, temibili, dei sacerdoti della fruttuosa retorica resistenziale54»,
è una presa di posizione di parte, infinitamente lontana dall’invocato amore per la verità; e qui non si tratta di «retorica resistenziale» ma piuttosto di realtà fattuale.
Quanto all’italianità dei “territoriali della Wehrmacht”, vittime dell’attentato di via Rasella, Messori vuole, ancora una volta, costringere la realtà fattuale nella sua limitata realtà. Prima di ogni altra considerazione, mettiamo le cose al loro posto: i militari altoatesini non erano della Wehrmacht, ma facevano parte delle SS e appartenevano all’11a compagnia del 3° battaglione Bozen55. Secondo la sentenza della Cassazione dell’agosto 200756, che condannò Il Giornale per diffamazione di Bentivegna e degli altri esecutori, i “vecchi territoriali della Wehrmacht” erano uomini validi, compresi tra i 26 e i 43 anni, armati di tutto punto: sei bombe a mano e una pistola ciascuno. E tedeschi lo erano per davvero: erano stati reclutati nella Zona di Operazioni Alpenvorland, il nostro Trentino-Alto Adige, che, il 10 settembre 1943, la Germania nazista aveva inglobato con un’azione di forza nel territorio metropolitano del Terzo Reich, dandogli appunto quella denominazione, senza che la repubblichina fascista alzasse un dito. Va poi detto che, contrariamente alla loro scelta iniziale, moltissimi tra coloro che optarono per la Germania nel 1939, non lasciarono mai l’Alto Adige. È dunque molto probabile che chi allora vestì i panni delle SS, prestando il giuramento nazista di fedeltà a Hitler, in un fluente tedesco, l’abbia fatto in piena coscienza. Anzi, la Cassazione dà il fatto per certo.
Quando Messori paragona l’attentato di via Rasella alla strage di piazzale Loreto, sbaglia: il termine di paragone corretto è l’attentato di viale Abruzzi. Comunque sia, quando afferma che quella non fu un’azione di guerra ma un’azione politica voluta dai comunisti, nega la legittimità della Resistenza e dimostra palesemente e ancora una volta il suo pregiudizio anti-antifascista. Con la costituzione della repubblica sociale italiana, si realizzò una situazione singolare: due Stati contrapposti reclamavano entrambi l’esercizio legittimo della forza e dell’autorità dello Stato sul medesimo territorio. Tra l’altro, la Resistenza, una volta riconosciuta dagli Alleati, riceverà anche la delega a rappresentare il governo legittimo dei Savoia nell’Italia occupata57. Era, dunque, inevitabile che ne scaturisse la guerra civile, la cui responsabilità ricade totalmente su Mussolini58, che barattò la sua libertà personale e la restaurazione del regime fascista con l’occupazione militare nazista dell’Italia settentrionale e centrale.
Messori asserisce che
«[…] a Roma, i tedeschi si sarebbero presto ritirati ma nel popolo romano non c’era sufficiente odio per loro, i lutti non erano stati tanto gravi ed estesi da risvegliare nella gente un furente antifascismo che essi, i comunisti, avrebbero poi utilizzato a dovere, usando ai loro scopi i “martiri”».
Insomma, il popolo romano odiava i tedeschi, ma non troppo. I lutti ci furono, ma non tanto gravi.
Forse, allora, il popolo romano, i tedeschi li amava, ma non tanto?
Mah! Chissà perché il popolo romano insorse in armi, mentre i vertici dell’esercito e dello Stato se la davano a gambe per salvare la pelle?
Ciò malgrado, Messori insiste:
«Un calcolo egualmente cinico fu fatto dai capi partigiani milanesi».
Solo il suo radicato pregiudizio anti-antifascista può permettergli di descrivere una mentalità partigiana59 così contorta e perversa, senza alcuna prova documentale, né almeno il coraggio morale di dichiarare apertis verbis che questa è solo una sua legittima, ma personale opinione. Tra l’altro, le modalità della strage delle Fosse Ardeatine, a seguito dell’attentato di via Rasella, erano così disumanamente sproporzionate, che gli stessi nazisti ritennero necessario tenerla ben nascosta, facendo saltare gli accessi alle cave con la dinamite, per evitare la temuta reazione popolare.
Che poi Messori, irridendo inconsapevolmente (?) le vittime, affermi
«Addirittura, rischiavano di diventare “simpatiche” ai milanesi persino le SS che avevano rilasciato centinaia di operai arrestati e destinati al lavoro obbligatorio nel Reich.»
è un falso: gli “operai arrestati e destinati al lavoro obbligatorio nel Reich” non furono affatto rilasciati ma deportati in Germania e solo la metà di essi fece ritorno in Patria. Ed è un’invenzione di Costa la pretesa operazione di pubbliche relazioni, poi ripresa da Messori, come si è già dimostrato, anche perché smentita da testimoni60 e da documenti nazisti61> e fascisti62 che non ne fanno alcun cenno. Anzi: alla prova dell’analisi scientifica, l’affermazione sulle SS, che “rischiavano addirittura di diventare simpatiche”, diventa, come minimo, ridicola, se non offensiva dell’intelligenza del lettore!
E dal ridicolo, poi, si passa al farsesco quando Messori non si prende nemmeno la briga di controllare e correggere l’errore topografico di Costa, che scambia viale Abruzzi63 con viale Lombardia, che nasce in piazza Piola e finisce in piazza Durante, mentre Costa lo fa sbucare in piazzale Loreto! Anche nel 2005, era sufficiente usare internet per verificarlo; senza contare poi che, Messori era a Milano e poteva controllare direttamente in loco.
Quando egli scrive che
«I morti furono sette: cinque soldati tedeschi, compreso il grosso maresciallo, e due popolane milanesi.» e i feriti «furono una trentina»,
ripete servilmente le tesi di Costa, che i testimoni e i documenti dimostrano essere palesemente false, senza nemmeno tentare di correggere gli errori: non ci furono morti tedeschi; quelli civili furono sei, tra i quali una donna che fu identificata dal marito nel pomeriggio dell’attentato; i feriti furono undici, di cui cinque gravi, come dice il pluricitato rapporto del capitano Formosa della GNR.
Se le memorie di Costa hanno valore di documento della mentalità fascista e di come, in quel campo, si vivessero certe vicende, dovrebbe essere compito di Messori, che si improvvisa storico del fascismo e della Resistenza, confrontarle con altre fonti e altri documenti per vagliarle e verificarne il grado di attendibilità. Cosa che puntualmente Messori evita di fare per costruire una verità storica – a essere buoni – molto soggettiva che possa essere compressa a forza entro i confini ristretti dei suoi pregiudizi. Povero e maltrattato Marc Bloch!
E, ancora: i fucilati, come si è già detto, furono quindici e non diciassette; la strage fu eseguita alle 5.45 del 10 agosto 194464 e terminò alle 6.10; la stele odierna, a memoria della strage dei quindici partigiani, sorge nell’aiuola posta in via Andrea Doria, ove fa angolo con piazzale Loreto. Infine, per accertare che l’eccidio avvenne a fianco del distributore Esso, a cui fu appeso Mussolini, dalla parte dell’angolo di piazzale Loreto con via Andrea Doria, dove oggi ci sono gli uffici di una nota banca milanese, basta il confronto delle storiche fotografie dell’esecuzione con le foto attuali e la visione odierna di quell’angolo.
E, per concludere, ecco l’immancabile mozione degli affetti:
«Anche qui, dunque, come a Roma, nessuna giustificazione “militare”, solo motivazioni politiche che, tra l’altro, portarono alla morte anche di due donne del popolo con le loro povere borse e delle quali nessuno ha mai parlato».
Falso come Giuda: nell’attentato di viale Abruzzi, che generò la strage di piazzale Loreto, morì una sola donna, Anna Berlesi, che passava casualmente per quel luogo e quindi, non era in fila per ritirare i fantomatici prodotti alimentari distribuiti gratuitamente dal “generoso” esercito nazista. A costo di diventare noiosi, dobbiamo ripeterci: è stato ampiamente provato che quella “generosa distribuzione”, inventata di sana pianta, in primis, da Costa e fatta, poi, propria dalla destra neofascista e dalla vulgata anti-antifascista, non ci fu proprio.
Se pressapochismo e/o malafede ci fu mai nell’analisi della storiografia della Resistenza, al fine di piegare la realtà storica nei limiti angusti dell’anti-antifascismo, questa fu proprio la narrazione della strage di piazzale Loreto, scritta da Vittorio Messori, per il Corriere della Sera, il 26 aprile 2004.
Indro Montanelli. Il principe dei bugiardi
Di Indro Montanelli si è scritto e parlato molto fin da quando era in vita. Della sua movimentata e straordinaria vita privata e professionale si sa praticamente tutto; quindi, abbiamo preferito metterne qui in evidenza gli aspetti “resistenziali”, limitandoci a una sintetica scheda degli altri aspetti della sua arcinota vita professionale
Montanelli nacque a Fucecchio nel 1909, in una famiglia medio-borghese: il padre era insegnante di lettere e poi preside; la madre, casalinga, era figlia di ricchi commercianti di cotone. Conseguì la maturità classica nel 1925 al liceo di Rieti, dove il padre, lì trasferito, era preside. Nel 1930, si laureò in legge a Firenze con una tesi sulla legge Acerbo. Nel 1932, conseguì una seconda laurea in scienze politiche.
Nel corso della guerra coloniale in Etiopia (1935-36), cui partecipò col grado di sottotenente, il ventiseienne Montanelli ebbe una relazione di madamato (convivenza more uxorio) con una ragazzina eritrea di 12 anni, Fatìma, malgrado che già allora la legge italiana65 vietasse i rapporti sessuali con minori di 14 anni, considerandoli violenza carnale. Comprò Fatìma versando al padre la cifra di 500 lire, oltre a un cavallo e un fucile. La moglie bambina lo seguì per l’intera permanenza in Africa; l’abbandonò, poi, al suo destino, cedendola al generale Pirzio-Biroli, nell’agosto 1936, quando rientrò in Italia.
Nel settembre 1938, entrò nell’organico dell’allora fascistissimo Corriere della Sera, diretto da Aldo Borelli, grazie a Ugo Ojetti; l’incarico escludeva categoricamente la cronaca politica. Il 12 settembre 1943 non si ripresentò in redazione e si nascose in casa di amici. Nel febbraio 1944 fu arrestato come profittatore di regime e per aver pubblicato articoli diffamatori del fascismo. Evaso dal carcere di san Vittore, con la complicità dell’agente dell’OVRA Luca Ostéria66, riparò in Svizzera. Rientrò in patria a fine 22 maggio ’45 e tornò al Corriere, ove rimase fino al 1973, uscendone in polemica con la proprietaria Giulia Maria Crespi e con Piero Ottone, allora direttore della prestigiosa testata, non condividendo la linea editoriale che strizzava l’occhio alla sinistra istituzionale. Diede le dimissioni, anticipando il licenziamento preannunciatogli verbalmente da Ottone, non avendo, la proprietà e la direzione, gradito le dichiarazioni polemiche sulla linea editoriale rilasciate da Montanelli al settimanale Panorama.
Grazie al generoso finanziamento di 12 miliardi di lire per tre anni da parte di Eugenio Cefis67, presidente della Montedison, Montanelli avviò il progetto di un quotidiano tutto suo, Il nuovo Giornale, che vide la luce nel giugno 1974. Collaborarono alla nuova testata, di cui ovviamente Montanelli era il direttore, firme illustri del giornalismo e della cultura italiani.
Nel 1977, al termine del finanziamento Montedison, Montanelli accettò il sostegno di Berlusconi, che sottoscrisse il 12% delle quote della società editoriale e che, nel 1979, divenne socio di maggioranza con il 37,5%. Berlusconi raggiungerà la maggioranza assoluta nel 1987, quando i giornalisti-azionisti gli cedettero le loro quote per ripianare i debiti cumulati dalla cooperativa editrice. Nel 1992, egli fu costretto a cedere formalmente il pacchetto azionario al fratello Paolo, per evitare le sanzioni della legge Mammì, approvata nel ’90, che poneva limiti precisi alla concentrazione della proprietà di mezzi di comunicazione. Il rapporto societario e amichevole tra i due si guastò, fino ad arrivare alla separazione, quando Berlusconi, simpatizzante del centrodestra, nel 1994, decise di “scendere in campo” per difendere le sue scelte industriali, mentre Indro si schierò su posizioni diverse e più moderate.
Montanelli fondò La Voce, in cui confluì oltre il 70% dell’organico dei giornalisti de Il Giornale. L’ultima creatura di Montanelli, dopo un iniziale buon risultato di vendite, in pochi mesi, crollò a meno di centomila copie vendute. La Voce fu costretta alla chiusura a metà aprile 1995.
Montanelli tornò al Corriere della Sera, dove curò la rubrica La Stanza di Montanelli, con un considerevole successo. Quando uscì Il libro nero del comunismo espresse i suoi dubbi sulle reali cifre riportate dagli autori e disse che il libro non rivelò nulla che non si sapesse già. Allo stesso modo, reagì alla pubblicazione del Dossier Mitrokhin, definendolo una “patacca”.
Morì, il 22 luglio 2001, a Milano nella clinica La Madonnina, in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico.
Montanelli, malato cronico di egolatria, costruì la sua immagine con cura maniacale, senza rispetto alcuno per la realtà fattuale, al solo scopo di erigere un leggendario monumento della sua immagine. Si sono ispirati a questa narrazione i suoi pseudo biografi, in genere colleghi o agiografi che, ligi al culto della personalità, riconobbero in lui il loro maestro. I suoi “discepoli” lo proclamarono “principe dei giornalisti”, mentre sarebbe più opportuno definirlo “principe dei bugiardi”68.
Solo per fare qualche esempio, l’anno che intercorre tra l’ottobre ’34 e l’ottobre ’35, avrebbe dovuto essere di oltre 500 giorni perché Montanelli potesse riuscire a lavorare freneticamente prima a Parigi, a Nouvelle Italie, nota testata fascista francese69; poi per 10 mesi a Paris Soir, comprendendo un viaggio in Canada da inviato per quel giornale; e, poi, a New York, a lavorare per la United Press70. Ma di tutto ciò non c’è traccia né nell’archivio UP71, né nell’archivio dei visti di ingresso negli USA72.
Montanelli appena giunto in Svizzera fece tre dichiarazioni tanto clamorose quanto false73 che riguardavano: 1. la sua c.d. “evasione” da S. Vittore; 2. il supposto “processo” conclusosi con la sua pretesa “condanna a morte”, emanata dai nazisti; e 3. il mai formulato incarico di «organizzare la stampa clandestina, su ordine del CLN». I milanesi lo definirebbero un «baùscia» o, meglio, un «casciabàl», come chiamano chi, per farsi bello, le spara grosse e ingigantisce la verità.
In Svizzera, durante il soggiorno luganese, si vantò del suo antifascismo, ma fu imprudente e, soprattutto, ebbe toni sprezzanti per gli antifascisti. Per presunzione, superbia o cinismo, bruciò Ostéria agli occhi degli Alleati, parlando troppo e incautamente del ruolo ch’egli ebbe nella sua “evasione” da San Vittore: pochi mesi dopo, Ostéria fu arrestato dagli inglesi.
Montanelli si lamentò sempre dell’ostracismo dei fuorusciti, che, disse, lo trattarono “come un cane”. Ma gli antifascisti luganesi erano gente dura, di spessore morale e politico indiscutibili: si chiamavano Ernesto Rossi (13 anni di carcere), Umberto Terracini (18 anni in cella), Altiero Spinelli (17 anni, tra cella e confino). Diffidarono subito di chi «era arrivato in macchina in orario da matinée teatrale, con una ricca americana e un generale di secondo piano, guidata da una spia filotedesca che salutava sorridente le SS ai posti di blocco74». E ne avevano tutte le ragioni: Montanelli fascista era e fascista rimase anche nel dopoguerra. Quando si presentò a Filippo Sacchi, che era stato direttore del Corriere della Sera, questi commentò:
«Guardo come un portento quest’uomo che se ne è venuto via [dall’Italia] lasciando la donna che ama in quelle grinfie, dopo avercela messa lui con la sua imprudenza»75.
Eppure, Leo Valiani gli fece un’apertura di credito, sia pur minima:
«Montanelli vale forse più di ogni altro giornalista italiano, come scrittore».
Ma poi aggiunse:
«Nei suoi libri di storia non porta la ricerca fino in fondo. Dopo tutto, non è uno storico di professione neanche lui, però coglie spesso il punto essenziale nel racconto storico»76.
Nell’autunno ’43, Montanelli chiese aiuto a Filippo Beltrami, architetto milanese, capo partigiano che operava nella zona dell’Ossola e del lago d’Orta, nome di battaglia il Capitano. Ma il giornalista, megalomane come suo solito, rivoltando la frittata, ha sempre raccontato che fu Beltrami a chiamarlo per dargli il comando di una formazione partigiana: tutto inventato, testimonia la vedova Giuliana Gadola e conferma Renata Broggini77; Montanelli, «tagliato fuori dal gruppo del Partito d’Azione, in cui aveva cercato di entrare, perché i compagni non si fidavano di lui, sia per il suo passato fascista che per l’imprudente leggerezza di cui stava dando prova78», chiese aiuto ai Beltrami per scappare da Milano. Ma “il principe dei giornalisti” non salì mai in montagna: vita troppa dura e troppo lontana dalle comodità della sua. Si fermò a Pella, sul lago d’Orta, nella villa dell’ingegner Mario Motta, industriale antifascista, amico di Beltrami e suo compagno di lotta. Mentre era suo ospite, non si fece problemi di discrezione, né scrupolo alcuno a farsi notare mentre passeggiava tranquillamente per il lungolago.
Montanelli disse poi che il contatto con Beltrami saltò perché il Capitano quello stesso giorno fu catturato e ucciso dai tedeschi; ma Montanelli fu arrestato il 5 febbraio, mentre Beltrami fu assassinato una settimana dopo, il 13 febbraio. Con la sua condotta superficiale, causò anche la morte di Motta79, che, divenuto sospetto, fu da allora tenuto d’occhio dai fascisti repubblicani e, il 16 novembre ’44, fu prelevato e fucilato da due militi fascisti, travestiti da partigiani80.
Montanelli non fu mai partigiano
A ragione, Montanelli fu sempre ritenuto dagli antifascisti un fascista, forse pentito, ma certo inaffidabile; non gli perdonarono mai la cattura e la morte dell’architetto Filippo Beltrami, né quella dell’ingegner Motta, a lui ascrivibili per il suo incosciente, superficiale egocentrismo.
Tra l’altro, Montanelli non fu incarcerato a San Vittore per un articolo anonimo, sul Corriere della Sera, che illustrava pettegolezzi su Claretta Petacci, a lui ingiustamente attribuito, come egli volle sempre far credere; ma perché, sul Corriere del 24 novembre 1943, Mussolini l’aveva indicato come un “profittatore di regime”. A quell’epoca, c’era una bella differenza tra essere ricercato per antifascismo ed essere invece indicato come un ipocrita opportunista. D’altra parte, che interesse potevano mai avere i tedeschi per condannarlo a morte a causa di un articolo di pettegolezzi su Claretta? In ogni caso, non fu mai processato per antifascismo né, tantomeno, condannato a morte: tutte affermazioni sue, inventate di sana pianta, per certificare l’appartenenza all’antifascismo milanese, che lo aveva invece rifiutato, non credendo alla sua conversione dell’ultima ora.
Non si possono, infine, non fare alcune considerazioni che sono significative della povertà morale e intellettuale, di questo preteso grand’uomo, del suo smisurato cinismo e di una visione strumentale di ogni legame, anche il più intimo e stretto, fosse esso affettivo, di amicizia, o anche di semplice conoscenza.
La prima riguarda Fatìma, la moglie bambina comprata da Montanelli per 500 lire, un cavallo e un fucile, abbandonata al suo destino, al suo rientro in Italia, dopo poco più di un anno di convivenza. Montanelli la considerò e la trattò alla stregua di un “genere di conforto”, condotta che oggi gli costerebbe l’accusa di pedofilia e il carcere. Al di là dei codici di allora e di oggi, c’è da chiedersi che razza di uomo sia chi si comporta in quel modo, senza porsi il minimo dubbio morale.
La seconda riguarda la moglie Margareth Colins de Tarsienne, detta Maggie. Egli la fece arrestare per la stupida leggerezza di volerle far consegnare un biglietto tramite l’autista di Motta (la loro casa di Milano, in piazza Castello, era sorvegliata); e, con la sua inconsapevole moglie, fu arrestato anche lui. Dopo averla sostanzialmente abbandonata nelle mani dei fascisti che li ricercavano entrambi, la lascia sola ad affrontare il suo destino, che la porterà ad essere internata nel campo di concentramento di transito di Gries, presso Bolzano; dove, peraltro, Maggie si comporterà tanto lealmente verso le sue compagne di detenzione, da meritarne il rispetto. Dal suo confortevole rifugio svizzero, Montanelli si preoccupa ben poco del destino della moglie. Ciò malgrado, Maggie, grazie alla conoscenza del tedesco, sua lingua madre, e a una buona dose di fortuna, riuscì ad evitare la deportazione in Germania.
La terza riguarda invece l’ambiguo comportamento verso la famiglia di Vittorio Gasparini, suo compagno di infermeria in carcere. Montanelli ne ammira la statura morale e la tempra di cattolico, che Gasparini dimostra con la sua lealtà verso i compagni di lotta, tacendone i nomi, malgrado le torture, o fornendo solo quelli dei caduti. Entusiasta, egli ne celebra le doti di lealtà e di coraggio nell’articolo intitolato “Vittorio Gasparini” sul quotidiano di Bellinzona “Popolo e Libertà” del 21 settembre 1944, in cui descrive, in toni epici, il momento della selezione di Gasparini tra i destinati alla fucilazione. Ma Montanelli, quando Gasparini fu selezionato per la fucilazione in piazzale Loreto, era già “evaso” da nove giorni81! L’articolo, è molto coinvolgente, ma, per bello che sia, è una fandonia colossale, e fa sorgere il dubbio che l’elogio funebre, scritto dal comodo esilio svizzero, non sia altro che la strumentalizzazione dell’episodio per accreditarsi come partigiano e antifascista, da una parte; e, dall’altra, per ottenere la benevolenza della famiglia Gasparini, cui chiede anche un aiuto economico, in una lettera dattiloscritta con firma autografa82, agli atti del processo Saevecke.
La quarta considerazione riguarda l’equivoco e poco trasparente ruolo che Montanelli gioca nei confronti della Resistenza. Il “partigiano” Montanelli non esita a gettarsi nelle braccia di Luca Ostéria, doppiogiochista agente provocatore dell’OVRA, pur di salvare la pelle. Salvo, poi, bruciarlo, con la sua solita superficialità, parlando urbi et orbi del suo ruolo nell’“evasione” da San Vittore. Egli poi, nel corso della sua testimonianza, riferisce che il capitano delle SS, Theodor Saevecke, comandante della sicurezza nazista a Milano, e responsabile del raggio tedesco di San Vittore, avrebbe saputo della sua evasione e avrebbe chiuso un occhio; ma è davvero problematico stabilire se ci sia stato un qualche avallo dell’inflessibile nazista in quella poco trasparente “evasione”. Tuttavia, non si può evitare di mettere in evidenza la disinvoltura con cui il “partigiano” Montanelli salta da una parte all’altra, senza alcuna dignità né scrupolo83, pur di salvare la pelle.
Altro che morale adamantina: un vero e proprio opportunista voltagabbana!
Infine, a conferma dell’egolatria e del carattere disinvolto del “principe dei giornalisti”, al termine della sua deposizione, nella sessione milanese del processo Saevecke, ad Alberto Custodero, giornalista di Repubblica, che gli fa notare l’indignazione suscitata nei parenti delle vittime dalla disinvoltura con cui Montanelli ha stravolto i contenuti della lettera scritta alla famiglia Gasparini, nel ’44, a poco più di un mese dalla strage, il preteso grand’uomo risponde senza alcuna vergogna né rispetto per il dolore dei parenti, anzi, con il consueto egocentrismo e maleducato disprezzo: «Rumoreggino pure, me ne fotto dei loro rumori. Io le bugie non le dico84». E questo subito dopo averne detta spudoratamente una madornale, pur di favorire Saevecke!
Se ha evitato l’accusa di falsa testimonianza lo deve esclusivamente alla palese ammirazione che il presidente della corte, dr Saeli, gli manifesta.
Nel dopoguerra, invece, getta la maschera: non ha più la necessità di spacciarsi per partigiano – anzi, tutt’altro! Matura un anti-antifascismo, di cui sarà l’antesignano, che lo porta, addirittura, ad intrecciare uno scambio epistolare con Saevecke, al quale manifesta la sua riconoscenza per avergli “permesso” di evadere; giunge poi fino al punto di schierarsi con lui, come teste a difesa, senza peraltro portare alcun elemento significativo, nel processo che si concluderà, nel 1999, con la condanna all’ergastolo del criminale di guerra.
La capacità di Montanelli di strumentalizzare e volgere a proprio favore anche le situazioni più difficili e drammatiche, dimostra un amorale cinismo e un’egoistica disonestà intellettuale che suscita insofferenza e antipatia; o, per converso, ammirazione, nei cinici opportunisti come lui.
Nota metodologica
Nel vagliare, per quanto possibile, la documentazione nota allo stato attuale e le fonti necessarie a mettere a fuoco il periodo “partigiano” di Montanelli, non abbiamo preso in considerazione le biografie né, tanto meno, le agiografie scritte dai giornalisti suoi discepoli, perché, sottoposte all’incrocio con altre fonti e/o documenti, si sono dimostrate inattendibili e assai meno veritiere dei lavori di chi, giornalista o scrittore, si è invece attenuto rigorosamente ai principi della ricerca storica. Un paio di esempi di quanto qui si sostiene: Marcello Staglieno, quando Montanelli dice che Beltrami fu arrestato lo stesso giorno in cui fu arrestato lui (Beltrami fu arrestato il 13 febbraio, Montanelli il 5), ne giustifica l’errore e lo attribuisce a «una crasi mnemonico-temporale, questa di Montanelli, comprensibile…»; e ancora, quando la Broggini smonta la versione di Montanelli sul maggiore (o generale) Böhme, Staglieno prontamente lo giustifica come «un errore mnemonico»85 di Montanelli.
Ebbene, nella storiografia scientifica non sono accettabili testimonianze contenenti “crasi mnemonico-temporali”, o “errori mnemonici”: dichiarazioni di tal genere, essendo unilaterali e non verificabili, semplicemente non possono entrare a far parte della narrazione storica; anzi, devono far dubitare dell’affidabilità della fonte. Essendo una prassi unanimemente condannata dalla comunità scientifica, utilizzarle è una forzatura inammissibile per chi voglia proporsi come storico degno di fede.
Analisi de «L’Italia nella guerra civile»
Fin dall’Avvertenza a pagina 3, Montanelli comincia proprio male:
«Io, arrestato dalla Gestapo per partecipazione ai gruppi di Giustizia e Libertà, rimasi in prigione fino al settembre ’44, prima a Gallarate, e poi a S. Vittore, donde riuscii ad evadere e a riparare in Svizzera. …».
La partecipazione ai gruppi di Giustizia e Libertà di Montanelli non è neppure ancora iniziata (in verità, non iniziò mai) e già commette molti errori per superficialità e leggerezza che lui pagherà con il carcere mentre, in periodo di tempi bui, il “Capitano” Beltrami e l’ingegner Motta pagheranno con la vita la sua irresponsabile superficialità, come abbiamo visto. E, benché fare la vittima, per volgere a proprio favore la benevolenza dei lettori, e raccontare fandonie sia una specialità di Montanelli, è necessario ricordare che egli non rimase in carcere fino al settembre ’44: la sua cosiddetta “evasione” avvenne il 1° agosto 1944, organizzata fin nei minimi particolari dall’agente doppiogiochista dell’ OVRA, Luca Ostéria, forse con l’avallo di Saevecke e di Rauff. Riparò poi in Svizzera, due settimane dopo.
E, a pagina 4, sempre dell’Avvertenza, Montanelli scrive
«Quando, il 29 di aprile, andai a vedere la macabra (e ripugnante) scena di piazzale Loreto…».
Peccato che non abbia mai potuto “vedere la macabra (e ripugnante) scena” dell’esibizione dei cadaveri di Mussolini, Claretta e dei gerarchi in piazzale Loreto: la Svizzera lo rilasciò solo il 22 maggio 1945, circa un mese dopo86.
E veniamo finalmente alla strage di piazzale Loreto. Montanelli, a pagina 208, azzarda avventatamente un paragone tra le stragi di Marzabotto, delle Fosse Ardeatine e quella di piazzale Loreto:
«A Marzabotto fu praticata la strage per la strage, gratuita. Il suo unico risultato fu di suscitare odio. Per questo ancora più odiosa, Marzabotto, delle Fosse Ardeatine, un massacro che almeno aveva la sua giustificazione nel codice di guerra: e quindi più odiosa anche dell’altro eccidio di piazzale Loreto a Milano, dove il 9 agosto i gappisti avevano fatto saltare, in viale Abruzzi, un autocarro militare germanico: cinque soldati morti sul colpo, altri quattro nei giorni successivi, a causa delle ferite. Kesselring voleva che fosse applicata anche lì la regola del dieci per uno, poi l’arcivescovo Schuster riuscì, supplicandolo, a ridurre da cinquanta a quindici il numero degli ostaggi da sacrificare. Un plotone d’esecuzione di fascisti sterminò accanto al distributore di benzina di piazzale Loreto, all’alba del 10 agosto, i prescelti, tutti detenuti politici, prelevati da San Vittore. Come macabro contrappasso a quel sacrificio di antifascisti, Mussolini e Claretta Petacci finirono poi appesi a quello stesso distributore. …».
Montanelli e Cervi non sanno neppure di cosa stanno parlando. La strage di Marzabotto (dal maggiore dei comuni colpiti), ma, più correttamente, l’eccidio di Monte Sole, fu un insieme di stragi compiute dalle truppe nazifasciste tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, alle pendici di Monte Sole, in provincia di Bologna. Durante la Seconda guerra mondiale, fu uno dei più gravi crimini di guerra compiuti dalle SS, in Europa occidentale, contro la popolazione civile, che costò la vita a 955 persone. Lo scopo era fare “terra bruciata” attorno alle formazioni partigiane nelle retrovie della Linea Gotica, sterminando le popolazioni che le appoggiavano.
Quindi, affermare che «A Marzabotto fu praticata la strage per la strage, gratuita. Il suo unico risultato fu di suscitare odio…» è quanto meno azzardato e dimostra la superficialità con cui i due autori si sono documentati per raccontare la strage di Monte Sole, in particolare, e la storia della guerra civile in Italia, in generale. L’unica affermazione condivisibile e accettabile è che il risultato fu di suscitare l’odio delle popolazioni colpite.
All’opposto, il paragone con la strage alle Cave Ardeatine è sbagliato nei termini: in via Rasella furono uccisi dall’attentato della Resistenza Romana 33 militari tedeschi e furono fucilati 335 civili, cinque più del “necessario”, scelti tra ebrei, detenuti politici e comuni. Comunque, anche se Montanelli e Cervi cercano in tutti i modi di farcene dimenticare la dimensione criminale, adducendo come attenuante un inesistente «codice di guerra», sempre un crimine efferato resta.
D’altra parte, per la strage di piazzale Loreto si invoca il bando Kesselring, senza che ce ne siano i presupposti: in viale Abruzzi, a Milano, non ci sono morti tedeschi che invece Montanelli e Cervi indicano in cinque nazisti; anzi nove, perché altri quattro, feriti gravi, “moriranno qualche giorno dopo”. Per inciso, vale la pena di osservare che la strage si prepara, in gran fretta, senza alcuna forma di pubblicità, né intimando ai responsabili di consegnarsi (come avvenne anche per l’attentato di via Rasella); si procedette direttamente all’esecuzione della condanna a morte, emessa non si sa da quale tribunale, senza alcun processo, all’alba del 10 agosto. In sintesi, tra l’8 (e non il 9), data dell’attentato di viale Abruzzi, e il 10, ci sono circa due giorni in cui possono essere morti i feriti gravi. Comunque, sorprende la superficialità della ricostruzione: se cinque soldati nazisti muoiono sul colpo e altri quattro nei [due] giorni successivi, applicando la regola del dieci a uno, dovrebbero essere fucilati novanta ostaggi prelevati dalle carceri. Invece no: i due autori parlano di cinquanta, ridotti poi a quindici per l’intervento del cardinale Schuster.
Si badi bene: non per la mediazione delle istituzioni milanesi della RSI, come vorrebbero far credere i neofascisti; Montanelli e Cervi, da buoni cerchiobottisti, sono sì, schierati a destra, ma non troppo. Come invece è ormai noto, la riduzione del numero dei destinati alla fucilazione fu dovuta al fatto, del tutto occasionale, che non fu possibile ottenerne più di quindici, come ha dichiarato la segretaria di Saevecke, Elena Morgante, nella sua deposizione alla 78th Special Investigation Branch87. Il Comunicato del Comandante della sicurezza, cioè Saevecke, documenta solo 26 gappisti «condannati, quale misura di rappresaglia, alla pena di morte», undici avranno «commutata la pena di morte nella condanna al penitenziario, ove rimarranno sino a quando non si verifichino altri atti di sabotaggio» come dice il Comunicato nazista dell’11 agosto ’44. In coda, si notifica che «Giuditta Muzzolon è stata “graziata”: sarà trasferita in un campo di concentramento». Segue l’elenco dei dieci ostaggi; infine, quello dei quindici fucilati e la data dell’avvenuta fucilazione: il 10 agosto.
Sorprendentemente, poi, Montanelli e Cervi sorvolano su ciò che accadde dopo la strage.
Nessun cenno all’oltraggio né al vilipendio dei militi fascisti di guardia ai corpi dei partigiani morti, presi a calci e sputi; un milite giunse perfino a pisciare in un angolo del distributore. Neanche parlano delle giovani ausiliarie della RSI, che, sprezzanti, si pulirono le scarpe nelle vesti dei fucilati; non un cenno all’obbligo, armi alla mano, dei passeggeri dei tram di scendere e andare a vedere l’accaduto, quasi che fosse uno spettacolo da ammirare; né dei passanti che furono dirottati dalle loro destinazioni con lo stesso obbligo e modalità.
Insomma, l’intimidazione spietata dei fascisti e dei nazisti fu feroce e ben diversa dal comportamento dei nazisti che, a Roma, consapevoli della disumanità della strage delle Ardeatine, fecero di tutto per evitare che fosse scoperta. Poche righe, ma piene di falsi storici che toccano sul vivo la ferita sempre aperta e il dolore mai sopito dei famigliari delle vittime, siano esse delle Cave Ardeatine, o a Milano, di piazzale Loreto e dei caduti nell’attentato di viale Abruzzi. Dei poveri partigiani fucilati e vilipesi, gli «assassini della memoria» Montanelli e Cervi hanno perso il ricordo, inducendo colpevolmente una memoria mutilata nel resto del Paese.
Non casualmente, l’atteggiamento di Montanelli e Cervi per quanto accadde oltre otto mesi dopo, sempre lì, in piazzale Loreto è di segno diametralmente opposto. Qui si tratta di Mussolini, della sua amante e dei gerarchi e gli autori manifestano un giudizio pietoso per le vittime e più che severo nei confronti degli esecutori; ma si sono ben guardati dall’esprimere analoghi sentimenti di empatica compassione per i quindici partigiani e di condanna per i fascisti che ne vilipesero i corpi.
«Audisio … Buttò i cadaveri di Dongo su un camion, a Giulino di Mezzegra prelevò gli altri di Mussolini e della Petacci che erano stati sorvegliati da due partigiani, con quel mucchio nel cassone si diresse verso Milano dove entrò in piena notte, e depositò il carico sotto la tettoia del distributore di piazzale Loreto. Altri quattro corpi furono poi aggiunti, e la messinscena completata più tardi issando alcuni corpi a testa in giù, come nel negozio del beccaio. Turpe scena da révolucion centroamericana o da colpo di Stato irakeno, che ha disonorato chi la volle, chi la consentì, e la folla eccitata che indecentemente si accanì contro i poveri resti, li insultò, li sputacchiò, li insudiciò in modo ancor peggiore. Infierì esultante, il “popolo”, su colui che aveva acclamato fino a non molti mesi prima. Cadorna parlò di “sconcio”, Parri di “macelleria messicana”. Secondo Valiani il colonnello americano Charles Poletti, neonominato governatore della Lombardia, approvò invece, dopo avervi assistito, la disgustosa esibizione, da Bocca sorprendentemente definita “atto rivoluzionario su cui si farà dell’inutile moralismo”»88.
Eppure, anche nella narrazione di un episodio come questo, che fa parte della storia nazionale, perché conclude una fase infausta – se non altro per i risultati drammatici in termini di vite umane, ma anche per la miseria economica e morale in cui la guerra gettò l’intero Paese – gli autori riescono a manifestare il loro anti-antifascismo e la loro nostalgia fascista.
Non solo non c’è proporzione tra i sentimenti che suscita la strage dell’anno prima e soprattutto le modalità indecenti e incivili del dopo strage, ma se ne rifiuta il nesso causale con la fine ingloriosa del dittatore, della sua amante e dei suoi gerarchi che è invece il vero motivo della scelta di Audisio. Manca, nella narrazione del primo episodio, ogni partecipazione anche solo umana, ogni sia pur minima empatia; mentre, nel secondo, con la scelta di parole sprezzanti («buttò i cadaveri, con quel mucchio») si vuole sottolineare la distanza che Montanelli e Cervi vogliono prendere dal volgo traditore: qui si narra con sentita partecipazione la fine dei “capi” per prendere le distanze dal “popolo”, inteso come plebe incivile e becera, che «infierì esultante». E si sottolinea la condanna esplicita del fatto, da parte dei capi del CVL e del CLN-AI, per esprimere una pesante condanna del lucido quanto profetico giudizio politico, del comandante partigiano Giorgio Bocca: “atto rivoluzionario su cui si farà dell’inutile moralismo”. Bocca ha ragione; e infatti accadde proprio quanto previde. È consapevole che la fine del regime fascista, violento e autoritario, che portò il Paese alla miseria morale e intellettuale prima ancora che economica, seminando lutti in ogni famiglia, deve essere sancita da un atto pubblico. Il corpo del duce deve essere esibito per certificare che non c’è più, neanche lontanamente, la possibilità che quel regime possa tornare a vivere: il 29 aprile 1945 non è morta la Patria, con buona pace di Galli della Loggia, è morto il fascismo. E, finalmente, possono tornare la libertà e la democrazia: è l’inizio di un difficile cammino verso la ricostruzione, anche morale, della nuova Italia.
Franco Bandini. Predica bene, ma razzola male
Franco Bandini, nato a Siena nel 1921, partecipò alla campagna di Russia nel 1942-43, come ufficiale d’artiglieria. Per più di quarant’anni, è stato giornalista del Corriere della Sera e inviato speciale dei settimanali La Domenica del Corriere, L’Europeo e Tempo. Negli ultimi tempi, collaborò saltuariamente anche a il Giornale.
Ha scritto diversi libri di storia, dedicati prevalentemente al Novecento italiano; di un certo interesse la sua opera «Tecnica della sconfitta», del 1969, edita da Longanesi, dedicata ai giorni che immediatamente precedettero e seguirono l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, a fianco della Germania nazista. Sempre per i tipi di Longanesi, nel 1965, pubblica «Il Piave mormorava» che, in un eccesso di ambizione, dopo cinquant’anni, vorrebbe proporre la verità storica sulla grande guerra. Nel 1972 pubblica «Le ultime 95 ore di Mussolini» nella collana degli Oscar Mondadori. L’ultimo suo libro, «Cono d’Ombra», SugarCo Edizioni, 1990, indaga sulla morte dei fratelli Rosselli. Nella sua produzione ci sono anche alcuni libri di fantascienza e il pamphlet «Il petrolio italiano», del 1955.
Lasciata Milano nel 1970, si ritirò a Colle Val d’Elsa (SI), dove è morto, nel 2004.
Analisi dell’articolo «Rappresaglia. Ecco come si comincia»
L’articolo compare su Il Giornale, allora diretto da Vittorio Feltri, il 1° settembre 1996 e comincia in questo modo:
«Basta pronunciare la parola “rappresaglia” che subito i politici, i giornalisti e i magistrati inforcano…»
Bandini si estranea dalla sua categoria, come se non fosse un giornalista di lungo corso, considerato che iniziò la sua lunga carriera di giornalista nel lontano 1945.
«…È lassù, in quelle rarefatte latitudini, che vengono elaborati i nuovi concetti-guida del giusto e dell’ingiusto: tra i quali quello secondo cui il soldato ha il diritto di non eseguire gli “ordini illegali”».
Con buona pace di Bandini, Gerhard Schreiber ha dimostrato in modo inequivocabile che, persino nel rigoroso esercito del III Reich, era possibile al soldato disobbedire agli ordini illegali senza subire conseguenze:
«…il già citato paragrafo 47 del Codice penale militare tedesco permetteva ai soldati della Wehrmacht e ai militari delle SS la disobbedienza nei confronti di un ordine criminoso, anzi ne proibiva l’esecuzione»89.
E, più recentemente, la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d’inchiesta sui crimini nazisti in Italia90, ci informa che il comandante del reparto tedesco, cui appartenevano le vittime dell’attentato di via Rasella, si rifiutò di impiegare i suoi uomini per la “rappresaglia”, senza alcuna conseguenza.
Prosegue Bandini:
«…Dopodiché avviene di chiedersi che cosa avrebbero dovuto allora fare migliaia di piloti della britannica RAF quando andavano a bombardare le città tedesche sulla base della risoluzione, ferrea e conclamata del Commodoro Harris, di uccidere quanti più possibile vecchi, donne e bambini per indurre i soldati al fronte ad abbassare le armi».
Egli dimentica che la guerra è stata scatenata da Germania, Giappone e Italia. E bisogna pur ricordare che sono proprio Germania e Italia a Guernica a sperimentare per prime la tecnica del terrore che la «tempesta di fuoco» dei bombardamenti aerei produce tra i civili91. Tecnica poi ripresa dai nazisti con i bombardamenti aerei di Londra, perfezionata successivamente con i lanci dei razzi V1 e V2.
«…Piazzale Loreto, 10 agosto 1944.
In quella afosa mattina di un giovedì qualunque, un plotone della “Muti” fucila quindici uomini estratti dal carcere nella notte. L’ordine è del Comando tedesco, a titolo di rappresaglia per la morte di quindici civili italiani, dilaniati da una bomba all’angolo tra piazzale Loreto e viale Abruzzi, due giorni prima».
Bandini, per la sua rielaborazione storica di terza mano, gioca su due tavoli, quello di Vincenzo Costa e quello di Pisanò, appena un po’ più documentato. Ciò si può dedurre dalla ripetizione di errori che sono ora dell’uno e ora dell’altro.
I morti, tutti italiani, sono sei mentre i feriti sono undici, di cui cinque trattenuti in ospedale: i rimanenti sei, feriti leggeri, sono “ritornati ai loro domicili” dopo essere stati medicati; tra loro, c’è Heinz Kühn, l’autista del camion tedesco. Dunque, la proporzione non è di uno a uno, come la frase dell’autore lascerebbe intendere e chiarisce poi.
«…Questa è una rappresaglia nella proporzione “semplice” di uno a uno, cioè definibile senza tema di scandalo, assai più moderata di quella adottata per esempio a Roma, mesi prima, in conseguenza della bomba di via Rasella».
“Assai più moderata”? Non essendoci morti tedeschi, la strage è arbitraria e del tutto illegale: il comando della sicurezza nazista invoca in modo illegittimo il bando Kesselring, che autorizzava la fucilazione di dieci italiani per ogni morto tedesco. Infine, il luogo dell’attentato è il numero civico 77 di viale Abruzzi che è a circa 700 metri dall’angolo indicato da Bandini92 che riprende pedissequamente Pisanò.
Per la pseudo scientificità con cui si cerca di giustificare la ragione numerica e, dimenticando di analizzare la correttezza della ratio politica, il paragone è vergognoso e sbagliato nei termini: in via Rasella, il legittimo atto di guerra della Resistenza Romana uccise 33 militari tedeschi; mentre, tra ebrei, partigiani, militari e prigionieri politici e comuni delle carceri, i nazisti fucilarono 335 persone, cinque più del “necessario”. In ogni caso, anche se Bandini cerca di relativizzare la strage di piazzale Loreto per attenuare l’entità del reato, si tratta pur sempre di un crimine di guerra. Infine, si invoca il bando Kesselring, senza che ce ne siano i presupposti: a Milano non ci sono morti tedeschi. Quindi, il crimine sarebbe ancor più grave, perché senza causa.
«…Un secondo mistero circonda allo stesso modo quel che successe poi. Il fatto è che venne impartito alle formazioni partigiane di montagna l’ordine di procedere alla fucilazione dei militari fascisti e tedeschi in loro mano, nella misura di tre per ciascuno dei quindici martiri del piazzale. L’ordine fu prontamente obbedito, con l’esecuzione appunto di 45 disgraziati, i quali andarono al creatore probabilmente ignorando a che dovevano la loro triste sorte».
Se, seguendo il ragionamento di Bandini, dovessimo relativizzare, dovremmo dedurre che, essendo il rapporto delle vittime della rappresaglia partigiana di tre a uno, esso sarebbe più civile del rapporto dieci a uno stabilito arbitrariamente dai nazisti a Roma. Ma non è questo il punto: il Bandini non si pone, neppure lontanamente, il problema di capire quali sono i motivi per cui si sta combattendo una guerra civile, mentre è in corso la guerra di Liberazione dall’occupazione nazista dell’Italia93.
«…Dall’insieme di queste fonti pare di capire che furono fucilati 30 militi e soldati italiani, e 15 tedeschi, forse in due luoghi diversi, probabilmente nell’ambito delle Divisioni ossolane di Cino Moscatelli. I 45, infatti, stando a due dei quattro autori citati, erano stati catturati in massa su alcuni treni qualche tempo prima…»
Ricciotti Lazzero ne “Le brigate nere” a pag. 66 dice testualmente: «Il comando delle brigate “Garibaldi” fa fucilare 30 prigionieri fascisti e tedeschi ed altri 15 fascisti che ha catturato su un treno nella Valdossola».
«…Sarebbe bene che gli istituti storici della resistenza facessero un po’ di luce su un episodio dopotutto non così secondario».
Raccomandazione sorprendente, data la pochezza dimostrata dall’autore nella ricerca di fonti e di documentazione autentica su cui l’articolo pretende di basarsi. Senza spiegarci, poi, perché, polemicamente, l’onere della ricerca debba competere ai soli Istituti Storici della Resistenza e non agli storici di ogni parte.
La migliore risposta a questa professione di anti-antifascismo è di Mario Isnenghi:
«Il meglio che la destra dichiaratamente fascista abbia prodotto in questi cinquant’anni rimane la vasta e selvosa attività pubblicistica di Giorgio Pisanò. Obiettivamente, non è molto. Non è certo su questo versante che si è dimostrato di avere le carte per ricostruire una plausibile e complessiva storia d’Italia»94
Dal 2000, anno di pubblicazione del libro curato da Collotti, sono passati molti altri anni, ma, nella sostanza, la critica di Isnenghi vale ancora oggi, benché la produzione storiografica della destra sia migliorata in qualità e quantità. Ma seguiamo ancora Bandini:
«…Durante quei foschi mesi, sia in Italia sia nel resto dell’Europa occupata, le fucilazioni di massa non si contano. Mai nessuna però che possa essere inserita nella sequenza “bomba-rappresaglia-rappresaglia della rappresaglia”, pericolosissima perché a carattere esponenziale. Accettandola si finirebbe per trovar “giusto” lo sterminio di un’intera città, in un tragico gioco di poker in cui ognuno rilancia, aumentando la posta».
Anche qui Bandini pecca di ignoranza, non si capisce se vera o strumentale, delle tecniche terroristiche attuate dalle forze armate naziste (non solo SS, ma anche Wehrmacht) nei confronti delle popolazioni dei territori occupati. Basterebbe ricordare la strage di Monte Sole (995 vittime tra vecchi, donne e bambini) nel nostro Appennino Tosco-Emiliano per capire che le tecniche naziste sono proprio di portare “lo sterminio di un’intera città”. O, in Francia, quella di Oradour-sur-Glane, vicino a Limoges, in cui i nazisti rasero letteralmente al suolo l’intera cittadina, senza alcuna preoccupazione per la popolazione civile che fu sterminata.
Non fu, dunque, per caso che tutta la resistenza europea reagì allo stesso modo, facendo proprie quelle tecniche e rivolgendole contro i nazisti che erano i carnefici e non le vittime, come la narrazione capovolta di Bandini vorrebbe lasciar intendere.
«Tuttavia, se l’ordine ci fu la provenienza è rimasta nel vago. Per la Enciclopedia, il Lazzero e Borgomaneri, si trattò del Comando generale delle brigate “Garibaldi”, …»
“Se l’ordine ci fu”? Sarebbe bastato che Bandini leggesse il volantino della Delegazione per la Lombardia del Comando generale delle Brigate e distaccamenti d’assalto Garibaldi datato 15 ottobre 1944 e rivolto “Al popolo di Milano, a tutti i lombardi!”, disponibile presso l’archivio INSMLI, volantini e manifesti, fasc. “Partito comunista italiano”.
Per trovare la documentazione necessaria ad evitare inutili polemiche e prediche sterili, basta cercare negli archivi, senza limitare la ricerca ai soli libri! E ancora Bandini:
«…in pratica [l’ordine fu] di Luigi Longo, per il Deakin, del Comando generale del Cvl che è cosa essenzialmente diversa, e del resto assai improbabile. Anche qui chiarimenti autorevoli sarebbero utili, non foss’altro che per procurare materiali di studio agli storici e ai politici che di tempo in tempo si affannano nelle Conferenze Internazionali a elaborare regole certe su diritti e doveri dei belligeranti…»
Sfoggio di qualunquismo inutile e dannoso per l’autore che predica bene ma razzola male, sottraendosi al dovere di «procurare materiali di studio agli storici» di cui dovrebbero, invece, farsi carico tutti gli storici del tema Resistenza. Quanto a diritti e doveri dei belligeranti, c’è da chiedersi perché questo avvenga solo oggi: Bandini non sembra essere neppure sfiorato dal dubbio che la vicenda de “l’armadio della vergogna” c’entri in qualche modo.
«…Ma non è qui il punto veramente centrale dell’intera questione, bensì nel carattere, identità e motivazioni dell’esplosione dell’8 agosto, dal quale prese le mosse, generando nel giro di due o tre giorni, direttamente o indirettamente, la morte di 75 persone: e delle moltissime altre che caddero tra il 25 aprile e il 6 maggio del 1945 per quella incandescenza degli animi le cui radici rimontavano, almeno in parte, ai “fatti” di piazzale Loreto».
Interessante confrontare il Bandini di oggi con quello dell’Oscar Mondadori “Le ultime 95 ore di Mussolini”, 1972, che a pag. 366, nota n. 1, dice:
«Nessuno che non abbia vissuto quelle tragiche giornate sa quale fu l’indignazione dei milanesi di fronte alla tragica esposizione dei Quindici Martiri [le maiuscole sono nel testo originale, n.d.a.], nell’agosto 1944. Fu veramente una misura infelice e, peggio, criminale…».
Ma Bandini ha messo a frutto il tempo trascorso: a pag. 365, Bandini parla di due militari tedeschi morti nell’attentato, mentre nell’articolo dei giorni nostri dice – finalmente! – che i morti furono tutti italiani, sia pur sbagliandone il numero. Quanto ai poveri morti del dopo Liberazione, ma perché la destra insiste a credere che la deriva della ventennale, aggressiva e violenta politica fascista (che costò la morte di diverse decine di migliaia di oppositori nel corso dei vent’anni e oltre di regime fascista), una guerra mondiale (costata oltre 60 milioni di morti, di cui siamo abbondantemente corresponsabili, nel continuum storico) e una guerra civile (il cui costo in vite umane è di oltre 100 mila persone) possa finire istantaneamente, come quando giriamo la chiave di avviamento per spegnere il motore delle nostre automobili?
«…Ebbene, anche qui, buio profondo: nessuno ha mai rivendicato quella bomba, nessuno ne ha mai indicato l’autore, nessuno ha saputo spiegarne le motivazioni. La bomba scoppiò, e basta».
Nel corso del processo Saevecke, chiamato a testimoniare, Pesce conferma che l’attentato non era stato effettuato dai GAP al suo comando. Pure Bandini ne dubita. Legittimamente? Almeno in parte, sì, perché quando scrive il suo articolo, Pesce non ha ancora testimoniato al processo Saevecke, che si terrà dal 1997 al 1999. Anche se, nel frattempo, l’ha detto e scritto innumerevoli volte.
Da qui in avanti la descrizione dell’attentato di viale Abruzzi è di terza mano, ricostruita utilizzando prevalentemente la narrazione dell’episodio fatta da Pisanò95, dando per scontato che sia vera, aggiungendovi – qua e là – un pizzico di Vincenzo Costa96 e molta fantasia per drammatizzare il fatto. Non male per chi pretende, a gran voce, dagli storici, rigore nella raccolta di documentazione e scientificità nella storiografia!
Siamo all’invenzione pura in funzione di un preciso obiettivo: piegare la verità storica al fine politico che si vuole perseguire. Il camion tedesco è fermo in Viale Abruzzi dalle tre di notte: fa parte di una colonna militare da cui si è staccato, probabilmente per un guasto97. Quindi, l’attentato è improvvisato e diretto contro le forze armate tedesche. Tutto il resto, ancorché commovente e pittoresco, è falso!
«Con una aggravante: si tratta infatti di un gruppo di madri e padri che, con i loro neonati in braccio, si assiepano attorno a un piccolo autocarro tedesco carico di bidoncini di latte fresco, distribuito gratis».
Narrazione tratta di peso da quella di Pisanò; ma Bandini ci mette del suo e inventa i bidoncini di latte, il caffè fatto di surrogato, il tutto colorito dall’esperienza del giornalista di lungo corso, che battendo i marciapiedi della cronaca, sa bene quali mezzi usare per far leva sui buoni sentimenti del lettore. L’«autocarro tedesco carico di bidoncini di latte fresco» è un “autocarro germanico con rimorchio targato WM 111092”98 vuoto.
«Spinti da impulsi personali e del tutto isolati, che ci rimarranno per sempre sconosciuti, ci pensa un anziano maresciallo della “Wehrmacht” che quando può e come può fa il giro delle campagne più a portata di mano con un piccolo camion, si rifornisce di latte e lo parcheggia, senza orari fissi, ma sempre nello stesso luogo, all’angolo tra viale Abruzzi e piazzale Loreto. Scende dal camioncino, traversa il viale per bersi in un bar quello che i giornali chiamavano aulicamente un «surrogato», ma che noi, disgraziati randagi, avevamo battezzato «caffù». Attorno al camioncino la folla dei padri e delle madri si divide il latte, con quella fratellanza che viene dalla comune disgrazia. Alle nove una mano inavvertita depone sul sedile della guida il suo ordigno mortale».
Il rapporto del capitano della GNR Formosa prova che il luogo dell’attentato è il numero civico 77 di viale Abruzzi che era (ed è ancora: la numerazione del viale non è cambiata) a oltre 700 metri dall’angolo indicato da Vincenzo Costa, ripreso da Pisanò e, poi, da Bandini. Il documento già ricordato dice che le esplosioni furono due ed avvennero alle 8,15 del mattino, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. Nel corso del processo Saevecke, Riccardo Milanesi testimonierà che, dopo il primo scoppio, lui e altri passanti accorsero per prestare soccorso e furono poi, a loro volta, vittime della seconda esplosione99.
«Nell’esplosione e poche ore dopo muoiono sei bimbi, una donna che non sarà mai identificata e due giovani padri. Tra i 13 feriti gravi, altri sei, tra bambini, madri e padri, spireranno il giorno dopo, portando il bilancio finale a 15 morti, sette feriti gravi e qualche decina di feriti leggeri. L’unico che se la cava è il maresciallo tedesco, per cui la strage rimane “affare italiano” al novantanove per cento».
Bandini mente per forzare il racconto e adattarlo al Comunicato tedesco, firmato “Il comandante della sicurezza”, cioè Saevecke, che parla di “sei innocenti bimbi”, “vittime di un nuovo atto di sabotaggio”. In realtà, i morti sono sei, tutti civili, tra loro una donna sconosciuta, che sarà riconosciuta dal marito nel pomeriggio di quello stesso giorno ed identificata per la signora Amelia Berlesi100. Con buona pace dell’invito al rigore dell’indagine storica invocato all’inizio dell’articolo e ripreso, poi, in chiusura in modo ancor più categorico. Come si è già dimostrato, queste sono fantasie inventate da Bandini per costringere la realtà nel suo quadro soggettivo per far quadrare i conti della «rappresaglia semplice uno a uno». Per esempio, sorprende che la variante Bandini tra i morti, immediati o successivi all’attentato, non dia conto del nome e cognome di neppur uno dei “sei innocenti bimbi” citati, per altro non provati da alcun documento. Infine, rispetto all’originale di Costa, ripreso anche da Pisanò, Bandini nella sua narrazione salva el Carlün, l’inesistente maresciallo tedesco.
«Quando un furibondo Comando germanico della “Sicherheit” ingiunge a quello italiano di procedere a una rappresaglia nella misura di uno per uno, Piero Barini [recte: Parini], prefetto, si dimette101. il cardinale Schuster interviene con slancio e coraggio, e lo stesso Mussolini protesta con violenza…».
Per quanto concerne il cardinale Schuster l’affermazione è falsa: il suo intervento è rivolto solo alla rimozione dei poveri corpi oltraggiati dei partigiani102; mentre, per l’intervento di Mussolini, è invece gratuita e non documentata da fatti o testimonianze, anche se riportata da altre fonti e data per vera.
«Ma è da notare che nessuno calca la mano sul “tipo” dell’attentato, quasi si temesse di mettere in moto una valanga catastrofica.
La verità è che la Repubblica di Mussolini e le stesse forze tedesche stanno camminando sul filo del rasoio. L’eco dell’attentato a Hitler non si è ancora spenta, con venti febbrili giorni di colpi di scena e di esecuzioni feroci».
Sorprendentemente, Bandini rinuncia a indagare la relazione eventuale tra l’attentato di von Stauffenberg a Hitler103 e la rappresaglia di piazzale Loreto che, quasi certamente, è anche una manifestazione di zelo di Saevecke, fanatico nazista, che tale rimarrà fino alla fine dei suoi giorni.
«… è possibile arguire, ora, che la paura di una insurrezione generale sia stata più forte dello stesso sdegno suscitato dal carattere dell’attentato».
Il capovolgimento di fronte, rispetto alla nota già riportata ne “Le ultime 95 ore di Mussolini”, è significativo della professionalità di Bandini che, evidentemente, ritiene normale attaccare l’asino dove vuole il padrone: all’epoca dell’Oscar, era l’editore Mondadori; alla data dell’articolo, è Feltri, allora direttore de Il Giornale, che pubblicò l’articolo.
«…Milano non aveva nessuna voglia di insorgere, e non aveva neppure i mezzi per farlo. Inoltre, la psicologia di tutti noi che vivemmo nelle città quei tragici mesi era sideralmente distante da quel che immaginano i giovani storici di oggi».
Paternalismo inutile e supponente, tipico di chi, come Montanelli, crede di saperla lunga e dice: “Io c’ero!”, a garanzia della verità storica. Insomma, «i giovani storici di oggi» peccherebbero di “presentismo”, cioè di studiare il passato con gli occhi del presente; errore da cui i docenti si sforzano di metterli in guardia, durante l’intero, lungo e faticoso corso degli studi universitari. Mi chiedo, per esempio, se Bandini abbia mai assistito a una sola ora di lezione di metodologia della ricerca storica, esame obbligatorio per gli studenti che oggi scelgono la specialistica in storia contemporanea.
«…Nel non riconoscere che lo stesso uomo sia diverso in situazioni diverse c’è già un primo grave errore. Ma il secondo è mortale. E sta appunto nel tramandare storicamente «lezioni» dei fatti adulterate al solo scopo di rimuovere colpe ed errori».
Dopo quanto abbiamo appena dimostrato, l’affermazione è tanto infelice quanto incauta. Bandini, dopo aver infilato una menzogna dietro l’altra, monta in cattedra e fa una lezione di etica e di morale sul modo di fare storia, neanche fosse un rinomato studioso della metodologia della ricerca storica del livello di Marc Bloch o di Jacques Le Goff. Verrebbe a mente, anche in questo caso, la già ricordata parafrasi di Michele Serra: il moralismo sta all’etica professionale dello storico come la cretineria sta all’intelligenza104.
«In altre parole, vogliamo ribattezzare piazzale Loreto, intitolandolo, almeno, ai «Trenta Martiri»?»
E perché no? Per Bandini è davvero difficile riconoscere che, se può cambiare idea tanto disinvoltamente, sia pure nel volgere di 40 anni, è merito della Resistenza che ha conquistato libertà e democrazia per il Paese e, dunque, anche per lui. E, allora, se proprio si deve ribattezzare piazzale Loreto, intitoliamolo pure ai «Quindici Martiri», visto che, con il loro sacrificio, hanno garantito la democrazia e la libertà a tutti gli italiani.
Daniele Carozzi. Quello del “latte in polvere”
Daniele Carozzi, laurea in Farmacia, dal 1984, ha unito l’attività di giornalista free lance, all’ esperienza di responsabile commerciale e marketing. È presidente pro tempore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Ha collaborato con varie riviste e giornali, fra cui “La Martinella di Milano”, “Il Giorno”, “La Prealpina”, “L’Uomo Qualunque” (direzione Lucio Lami) e “Il Giornale”. Dal 2010 collabora con il Corriere della Sera, in particolare per quanto riguarda cronaca, storia di Milano e argomenti di carattere militare. Ha pubblicato una decina di libri su tradizioni, storia e costumi di varie province lombarde ed è componente della giuria del “Premio Carlo Porta”, riconoscimento destinato a coloro che hanno dato lustro e prestigio alla città di Milano.
L’opera che ci interessa ai fini di questo studio è il suo Milano 1944. Villa Triste. La famigerata banda Koch, Edizioni Meravigli, 2014, in particolare le pagine che vanno da 72 a 74. È «un racconto romanzato, dove i fatti documentati e le testimonianze dei pochi superstiti rappresentano la verità storica105», secondo l’editore, «depurata sia dall’enfasi di chi aspirava all’aureola di eroe partigiano sia dalle minimizzazioni addotte dai seviziatori o dai fascisti».
Analisi di «Milano 1944. Villa Triste. La famigerata banda Koch»
Il libro “Milano 1944. Villa Triste” è un romanzo che pretenderebbe di essere storico, ma non è neppur degno di figurare in un catalogo di romanzi popolari, come Armony. Ci occupiamo di questo libello come limite qualitativamente inferiore dell’intervallo che abbiamo scelto come caso di studio per analizzare il modo in cui una certa stampa abbia approfittato del principio di revisione della ricerca storica, inteso come sacrosanto divenire della storiografia, in caso del rinvenimento di nuova docu-mentazione, per fare, invece, un uso pubblico della storia a fini politici. Quando Carozzi pubblica il suo “Villa Triste”: sono passati 15 anni dalla fine del processo Saevecke e la documentazione (2.500 pagine) è custodita, con diritto di accesso al pubblico, nell’archivio del Tribunale Militare di Verona senza ch’egli senta la necessità di consultarla! Come mai?
Semplice: in base al confronto analitico del testo di Carozzi con quello di Bandini, possiamo dedurre che la sua fonte documentale sia di terza mano, senza preoccuparsi di fare verifiche con altre fonti o documenti d’archivio; quindi, la sua è una narrazione di quarta mano. Certo, è più facile e comodo consultare l’archivio de «Il Giornale» di Milano che prendersi il disturbo di andare fino a Verona un paio di giorni e lavorare su vecchi documenti di difficile interpretazione, oppure andare almeno all’ Archivio di Stato di Milano, in via Senato, a fare un po’ di ricerca seria.
Nelle tre scarne paginette in cui descrive la strage di piazzale Loreto, senza dare alcuna indicazione sulle fonti da cui trae le sue notizie, Carozzi dà per certa una serie di fatti che certi non sono affatto. Anzi: lo sono, ma in senso diametralmente opposto a quello che egli assume come verità. In breve, il suo pregiudizio anti-antifascista costringe a forza, nel suo inaffidabile quadretto “storico”, fatti storici accertati sia in sede accademica che in sede giudiziaria, attribuendo loro significati diversi e contrari a quelli originali, senza alcuna argomentazione.
In questo modo, la Storia ne esce capovolta.
I nazisti, che esercitano il terrore assoluto e che, con la complicità dei fascisti repubblichini, fanno stragi disumane nel Nord Italia occupato, applicando i metodi brutali sperimentati – ahinoi! – con successo nell’Europa orientale, sono occupanti generosi: distribuiscono viveri e «latte in polvere106 [sic!]» alla madri per i loro neonati affamati dalla guerra e terrorizzati dai bombardamenti alleati.
I fascisti? Persone d’onore che tengono fede al giuramento fatto alla patria, identificata col partito fascista! Così, chi del fascismo non ne vuole più sapere, diventa automaticamente un traditore, e antifascista diventa sinonimo di comunista; perché per i repubblichini tutti gli antifascisti sono comunisti. Per Carozzi e la sua molto approssimativa metodologia di ricerca storica, è un particolare insignificante che la guerra l’abbia dichiarata il fascismo. Non si pone neppure il dubbio se ci siano responsabilità del fascismo repubblichino durante l’occupazione nazista del Paese, e quali sono eventualmente. Mussolini che, accettando la liberazione da Campo Imperatore, baratta la sua libertà personale con quella nazionale, che costituisce la RSI, e contrapponendosi allo Stato legittimo dei Savoia, crea le premesse della guerra civile, non ha alcuna responsabilità: è la vittima innocente di avvenimenti privi di qualsiasi rapporto causale con la sua attività politica. Le stragi dell’armadio della vergogna, oltre metà delle quali sono realizzate direttamente o indirettamente dai fascisti repubblichini, nascoste illegalmente dalla magistratura militare per oltre 50 anni, sono l’espressione più tragica e più imbarazzante di quella guerra civile.
Ma Carozzi non ne è per nulla imbarazzato.
Il suo furore anti-antifascista lo acceca a tal punto che gli impedisce di esprimere un qualsiasi giudizio morale su questa scandalosa vicenda, che include la strage di piazzale Loreto. Anzi, si permette di irridere sprezzantemente la Magistratura Militare degli anni ’90 che fa il suo dovere, indagando anche presso l’Obitorio milanese. «Che fine avranno fatto quelle indagini, rispolverate dopo cinquantatré anni»? si chiede sarcastico.
I morti nell’attentato di viale Abruzzi? Tredici contro i sei del rapporto fascista della GNR; ma da dove escano fuori quei sette morti di troppo non si sa; né è dato sapere, perché Carozzi, interpellato, si sottrae sistematicamente alla responsabilità di dichiarare le sue fonti. Pesce? Si è espresso sull’attentato in più occasioni, affermando che chi l’ha compiuto non faceva parte dei GAP e non era, quindi, al suo comando. L’ha pure testimoniato in tribunale a Torino. Ma neppure questo induce Carozzi almeno a dubitare: «[Pesce] non si esprimerà mai sull’attentato» è il suo inappellabile giudizio. Che dire poi dell’improbabile paragone con via Rasella? Inqualificabile. Due sole cose uniscono la strage delle Fosse Ardeatine a quella di piazzale Loreto:
-
-
- la mancanza della ricerca dei responsabili e
- la reazione immediata dei nazisti che definiscono “rappresaglie” entrambe le stragi.
-
Ma, il fatto che a Milano, nell’attentato di viale Abruzzi, non ci siano morti nazisti lascia indifferente Carozzi. A Roma, si nasconde la strage per timore della reazione popolare, data l’evidente efferatezza e la disumana sproporzione tra strage e antefatto. A Milano, la strage è esibita, i corpi sono pubblicamente vilipesi e oltraggiati in tutti i modi dai fascisti e dalle ausiliarie della RSI107; inoltre, per intimidire la popolazione e togliere ogni appoggio alla Resistenza, i cittadini in transito, a piedi, in bicicletta o sui tram, sono obbligati, armi alla mano, ad assistere all’infelice spettacolo.
E che dire del federale Costa che, nella narrazione di Carozzi, con «febbrili trattative», si adopera per contenere il numero dei fucilandi, come vuole la vulgata tanto cara alla destra fascista doc, neo e post? Affermazioni quanto meno avventate se non, addirittura, vergognose menzogne! Rimandiamo alla testimonianza dell’ex prefetto dell’epoca, dottor Alberto Bettini108, e a quella dell’Obersturmführer SS Eugen Krause109, appartenente all’Aussenkommando SS, già riportate nel IV Capitolo. Tutt’e due sono concordi nel dire che il fascismo repubblichino esigeva una punizione esemplare, con la fucilazione pubblica di 45 ostaggi (Bettini) o con l’impiccagione «di un centinaio di persone davanti alla stazione di Milano110» (Krause).
Ma neppure questo sembra scuotere l’adamantina certezza di Carozzi.
Ai fini di questa analisi, l’aspetto quantitativo è irrilevante: che i fascisti propongano di fucilare quarantacinque persone, o impiccarne cento, non sposta neanche di un capello la gravità morale e politica della proposta. Ciò che davvero conta è la spietata determinazione con cui il fascismo repubblichino vuole punire tutti coloro che ritiene traditori della patria, identificata con il partito. Che perseguire quei presunti traditori, significhi anche assumersi la responsabilità di una guerra civile, sembra importare assai poco ai fascisti duri e puri che oggi rimpiangono la RSI. Come a Carozzi, d’altra parte. Né l’autore si fa mai sfiorare dal dubbio che il traditore del Paese possa essere, magari, Mussolini, allora contemporaneamente capo della RSI, del governo e del partito. Quella disumana determinazione si vede dai numeri: l’impietoso rapporto delle perdite111 ammonta a circa l’85% in campo antifascista, rispetto al 15% in quello fascista.
Ma anche questo lascia Carozzi indifferente.
E, infine, dulcis in fundo, per la denigrazione finale della Resistenza, ecco la testimonianza di terza mano: il fidanzato di un conoscente avrebbe raccontato al Carozzi di una spia fascista infiltrata a S. Vittore; non riconosciuta e selezionata per la fucilazione, tenta la fuga in Corso Buenos Aires e sarà poi fucilata in Piazzale Loreto.
Marc Bloch si starà rivoltando nella tomba!
Dai documenti di fonte fascista e della CAS, per la maggior parte pure essi fascisti, che giudica gli assassini di Soncini, risulta provato che egli è l’unico che tenta la fuga. E la sua storia personale e politica dimostra che non è certamente una spia dei nazisti. Ma Carozzi ha l’impudenza di smentire anche questo!
Per questi motivi Carozzi deve essere incluso a pieno titolo nel poco ambìto novero degli «assassini della memoria». Da uno scambio di mail intercorso qualche tempo fa tra lui e chi scrive, pare che la cosa lo disturbi.
Purtroppo per lui, non c’è soluzione a questo problema; se egli intende continuare a scrivere di storia, sarà forse meglio che cambi metodo: sia più rigoroso nella ricerca storica; impari a fare un uso più accurato delle fonti, e, soprattutto, condivida con la comunità scientifica i risultati della sua ricerca, accettando il confronto e il controllo con gli storici che, studiando lo stesso caso, dichiarassero risultati diversi dai suoi. Altrimenti, il suo modo di fare storia è pura tautologia; come il bimbo che, non sapendo ribattere a chi gli chiede conto del suo dire, risponde: «Perché sì!». Insomma: quanto di più lontano dalla ricerca rigorosa e scientifica raccomandata da Marc Bloch.
Bruno Vespa, prigioniero dell’«editore di riferimento»
Bruno Vespa nacque a L’Aquila il 27 maggio 1944. Nel 1962, giovanissimo, Vespa divenne cronista radiofonico alla Rai e, nel 1968, dopo la laurea in legge, vinse un concorso nazionale per radio-telecronista e fu assegnato alla redazione del TG1, della RAI allora monopolista televisivo; dal 1976, ne fu inviato speciale. Nel 1969, in diretta, la prima gaffe: disse che Pietro Valpreda era il “colpevole” – anziché l’accusato – della strage di Piazza Fontana; errore di cui poi fu costretto a chiedere pubblicamente scusa.
Nel 1978, in un’edizione straordinaria del TG1, nel pomeriggio del 9 maggio, diede in diretta la notizia del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. La sera del 2 agosto 1980, per primo diede in diretta la notizia che la strage alla stazione di Bologna era il risultato di un attentato compiuto con una bomba. Dal 1990 al 1993 fu direttore del TG1. In questo periodo, fece scalpore una sua dichiarazione in cui affermava di considerare la Democrazia Cristiana il suo «editore di riferimento» e fu accusato di fare informazione di parte, accusa che non si scrollò mai di dosso.
Dal oltre 25 anni, su RAI1, l’ammiraglia televisiva della RAI, conduce ininterrottamente Porta a Porta, programma di approfondimento culturale, politico e di attualità che, con fine ironia, il senatore a vita Giulio Andreotti definì «la terza camera del parlamento italiano». Non casualmente, cinque giorni prima delle elezioni politiche italiane del 2001, Silvio Berlusconi, allora capo dell’opposizione, proprio a Porta a Porta firmò il cosiddetto «Contratto con gli italiani».
Vespa è stato spesso accusato di tenere un atteggiamento troppo compiacente verso la destra, per la sua evidente condiscendenza, e per l’eccessiva disponibilità verso Silvio Berlusconi. Frequenti furono le polemiche di cui Vespa è stato spesso protagonista; la più clamorosa avvenne in occasione della pubblicazione di una sua conversazione telefonica con Salvatore Sottile, portavoce dell’allora ministro degli esteri Gianfranco Fini, in cui Vespa concordò con Sottile la scelta del contraddittore di Fini (che fu poi Piero Fassino), in una puntata di Porta a porta, e promise: «La puntata gliela confezio-niamo addosso» [intendendo a Fini, nda].
Nel 2015, Il mondo politico e non si sono chiesti se fosse davvero necessario invitare alla sua trasmissione esponenti mafiosi e se non ci fossero altri interessi nelle presenze del clan dei Casamonica; e, nel successivo 2016, nella presenza del secondo figlio di Totò Riina, esponente di primo piano dell’organizzazione Cosa Nostra.
Nel corso della sua carriera giornalistica, Vespa è stato almeno sei volte citato in giudizio e condannato, talvolta con risarcimenti ingenti, per quanto da lui scritto o dichiarato nei confronti di personaggi pubblici o di semplici cittadini. Dovendo trarre da questi fatti una valutazione sull’attendibilità dell’autore, potremmo dire che, come spesso accade nella professione giornalistica, troppo frequentemente la necessità di rispettare i tempi stretti di uscita di un’opera, concordati con l’editore, prevale sull’accuratezza della ricerca delle fonti documentarie. Difetto, peraltro, comune a tutti quei giornalisti che si fanno conquistare dal desiderio di scrivere di Storia, specie, quella contemporanea.
La “narrazione storica” di Vespa si limita a un resoconto di eventi, scelti con cura in modo di bilanciare – almeno apparentemente – quelli della Resistenza e quelli della vulgata anti-antifascista, senza alcuna analisi del rapporto di causa/effetto che possa permettere al lettore di comprendere perché quegli avvenimenti si producano; o di chi e come ne abbia la paternità. Insomma, una narrazione cerchiobottista, con una deriva decisamente rivolta a destra, totalmente estranea agli insegnamenti di Marc Bloch.
Bruno Vespa ha scritto diversi saggi, in genere ben accolti dal pubblico dei suoi estimatori, raccolti in una collana e pubblicati da Rai Eri e Arnoldo Mondadori Editore con cadenza annuale dal 1993.
L’opera di Vespa che ci interessa ai fini dell’argomento di studio è Vincitori e vinti. Le stagioni dell’odio. Dalle leggi razziali a Prodi e Berlusconi, Roma-Milano, Nuova ERI-A. Mondadori, 2005.
Analisi di «Vincitori e vinti. Le stagioni dell’odio»
La narrazione della strage di piazzale Loreto di Vespa è piuttosto scialba, priva di passione e di spessore narrativo, soprattutto se, p.e., la paragoniamo a quella di Messori; d’altra parte, vi dedica appena una scarna paginetta, ma è quanto basta per infarcirla di errori madornali.
Vespa ricorre a Michele Tosca112 in qualità di fonte documentale, che si rivela essere una certificazione di quarta mano: Tosca, infatti, fa una sintetica quanto insignificante e banale parafrasi di un articolo di Franco Bandini (Rappresaglia. Ecco come si comincia, il Giornale, 1° settembre 1996), che, a sua volta, recupera Giorgio Pisanò (Storia della guerra civile 1943-45, FPE, 1964-65, pag. 926÷928) il quale riprende, corregge e lima Vincenzo Costa (Memorie, manoscritto degli anni ’50 – poi pubblicate da il Mulino, nel 1997, con il titolo L’ultimo federale. Memorie della guerra civile113).
Dunque, che Bruno Vespa scelga Michele Tosca significa che ha rinunciato in partenza alla ricerca di una verità, sia pure parziale e approssimata114, ma almeno onesta. Invece no: preferisce accontentarsi di un’unica fonte, non solo di parte, ma addirittura di quarta mano.
Nel 2005, anno di pubblicazione del libro di Vespa, sono disponibili i documenti ufficiali del processo Saevecke, che è iniziato nel dicembre 1997 e si è concluso il 9 giugno 1999, con una sentenza di condanna all’ergastolo dell’ex capitano delle SS Theodor Emil Saevecke, unico responsabile della strage di piazzale Loreto ancora in vita: dopo oltre cinquantacinque anni di occultamento del fascicolo, gli altri diciassette corresponsabili sono tutti deceduti. E, benché conosca l’armadio della vergogna115, ignora (o preferisce ignorare) che il fascicolo della strage di piazzale Loreto è uno degli oltre 695 nascosti nel famigerato armadio. Ma, soprattutto, Vespa ignora che quel fascicolo abbia prodotto un processo, alla cui oggettiva documentazione avrebbe potuto attingere per fare le opportune verifiche.
Invece, no. Fa una temeraria premessa che è quasi un gemellaggio con Messori perché, come lui, dimostra platealmente la sua pregiudiziale scelta di campo: «Eppure, anche di questa vicenda «parallela» non si conoscono i retroscena…».
Bruno Vespa riporta puntualmente, come fosse verità rivelata, le mistificazioni del modesto articolo di Tosca, che sono le stesse già denunciate per l’articolo di Franco Bandini, del 1° settembre 1996116, su il Giornale. Il camion militare con rimorchio diventa un “camioncino” comandato alla distribuzione del latte alle famiglie della zona. I morti sarebbero 15, tra cui sei bambini e una donna: Bruno Vespa adatta i morti italiani alla necessità di farlo coincidere con il numero dei fucilati del 10 agosto 1944. Se non parla di morti tedeschi è solo perché Tosca copia il Bandini del 1996, che invece ne contava due nel suo Oscar Mondadori “Le ultime 95 ore di Mussolini” del 1972. Riprende anzi la polemica sulle “rappresaglie delle rappresaglie” di Bandini che annovera 45 morti, tra fascisti e nazisti, fucilati dai partigiani per ritorsione della strage di piazzale Loreto.
Ad ogni buon conto, a sua insaputa, da oltre cinque anni, esiste già la consistente documentazione ufficiale del processo Saevecke, raccolta con notevole professionalità e diligenza, dalla squadra di storici che hanno assistito il PM, dr Pier Paolo Rivello, nell’istruzione dell’accusa. Quella notevole base documentale ha poi consentito al tribunale militare di Torino, di emettere, il 9 giugno 1999, una sentenza di condanna all’ergastolo del contumace criminale di guerra Saevecke, che diverrà definitiva sei mesi dopo per la rinuncia del condannato a ricorrere in appello. Insomma, la documentazione processuale dell’accusa, insieme alla sua arringa, a quella delle parti civili e della difesa, e, naturalmente, anche la sentenza di condanna, sarebbero una base importante per scrivere della strage di piazzale Loreto in modo circostanziato e non fazioso né superficiale.
Perché Bruno Vespa sente la necessità di non avvalersi di quella eccellente base documentaria e preferisce affidarsi a una fonte di quarta mano come quella di Michele Tosca? Difficile dirlo. Tuttavia, come già dimostrato per gli altri casi studiati, parrebbe che anche Bruno Vespa sia prigioniero del pregiudizio anti-antifascista che costringe la sua narrazione entro i suoi angusti limiti politici; in breve: non fa Storia, ma costringe la storia che vuole narrare entro limiti definiti a priori. È significativo della sua scelta di campo, che non riservi neppure una parola di pietà per i partigiani, i cui corpi furono pure offesi e vilipesi in modo vergognoso dai militi fascisti di guardia, come dalle ausiliarie della RSI che, in visita al funesto luogo, si pulirono le scarpe sui corpi in segno di disprezzo117. Eppure, non gli mancano parole pietose quando parla dell’esibizione del dittatore, della sua amante e dei gerarchi avvenuta il 29 aprile 1945, sempre in piazzale Loreto.
Ecco perché, dunque, anche Bruno Vespa merita l’appellativo di «assassino della memoria», che Pierre Vidal-Naquet assegna a coloro che non tengono nel minimo conto il dolore dei famigliari né il diritto alla verità che è loro proprio, come delle vittime. Va poi ribadito che quel diritto alla verità diventa un dovere verso la società tutta, quando si parla di eventi che, partendo dalla storia minima dei privati, investono successivamente la grande Storia.
È grave il fatto, infine, che il credito di cui Bruno Vespa investe Tosca, non si limiti alla strage di piazzale Loreto: nel libro «Vincitori e vinti», egli è richiamato altre quattro volte e ciò non depone a favore dell’attendibilità dell’autore né della sua tanto invocata imparzialità.
Note
[1. ] Cfr. Nicola Gallerano, L’uso pubblico della storia, Franco Angeli Editore, Milano, 1995, pag. 22.
[2. ] Pseudonimo di Eric Arthur Blair, celeberrimo autore inglese che scrisse «La fattoria degli animali» nel 1945 e il notissimo «1984», pubblicato nel 1948.
[3. ] Docente di Storia dell’antichità alla École des Haute Études En Sciences Sociales di Parigi. Ha scritto numerosi saggi sulla Grecia antica e sulla storia contemporanea.
[4. ] Titolo di un famoso saggio di Pierre Vidal-Naquet, edito in Francia nel 2005.
[5. ] Cfr. Deborah Lipstadt, La verità negata, Mondadori, 2016, pag. 13.
[6. ] Cfr. Edward H. Carr, Sei lezioni sulla storia, Einaudi, Torino, 2003, pag. 97.
[7. ] Cfr. l’articolo La storia fatta coi piedi, Wu Ming, utile sintesi della metodologia raccomandata da Marc Bloch. Vedi sito: https://www.wumingfoundation.com/giap/tag/marc-bloch/ consultato il 15 settembre 2021.
[8. ] Cfr. Claudio Pavone, Una guerra civile, citato.
[9. ] Cfr. Antonella Guarnieri, Nuovi documenti per lo studio della RSI a Ferrara, in AA.VV., Fascismo e antifascismo nella valle padana, a cura dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, CLUEB, Bologna, 2007, pag. 327.
[10. ] Capo dell’omonima, criminosa banda che operò a Roma dal dicembre 1943 al giugno 1944. Dopo la Liberazione di Roma, la banda Koch si spostò a Milano, ove divenne tristemente famosa per le torture inflitte ai partigiani nella Villa Fossati, in via Paolo Ucello, che i milanesi chiamarono subito Villa Triste.
[11. ] Giornalista e scrittore. Già penna di punta dell’Espresso, di cui fu anche vicedirettore, oggi noto come scrittore «revisionista»: nel 2001 scrisse «I figli dell’Aquila», romanzo con cui iniziò il «ciclo dei vinti» una serie di racconti su pretese violenze compiute da partigiani nei confronti di fascisti durante e dopo la seconda guerra mondiale. La forma del romanzo lo esime dal documentare certe sue affermazioni che capovolgono il suo precedente orientamento sulla guerra civile del 1943-45.
[12. ] Cfr. Silvia Buzzelli, «Nel processo penale «no habita el olvido»: crimini allarmanti, diritto alla verità e oblio illecito», in «Donde no habite el olvido. Herencia y transmisiòn del testimonio: perspectivas socio-jurìdicas», a cura di M. Rosti e V. Paleari, Milano, 2017, p. 27-34.
[13. ] Cfr. Hannah Arendt, La banalità del male, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2001, pag. 267-268.
[14. ] Cfr. le leggi Scelba e Mancino.
[15. ] Cfr. l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Conte che, l’8 settembre 2018, in occasione dell’inaugurazione della Fiera del Levante di Bari, ha incredibilmente confuso l’8 settembre con il 25 aprile!
[16. ] Cfr. http://ilfastidioso.myblog.it/2017/09/03/michela-murgia-il-fascismo-non-e-il-contrario-del-comunismo-ma-della-democrazia-dire-che-il-fascismo-e-unopinione-politica-e-come-dire-che-la-mafia-e-unopinione-politica/ visitato il 23 settembre 2021.
[17. ] Mario Isnenghi, I passati risorgono. Memorie irriconciliate dell’unificazione nazionale, in Angelo Del Boca, La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico, Neri Pozza, Vicenza, 2009, pag. 49.
[18. ] Mimmo Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919-1922, Mondadori, Milano, 2003, pag. 204-205.
[19. ] Vincenzo Costa, L’ultimo federale. Memorie della Guerra civile 194-45, a cura di G. Parlato, il Mulino, Bologna, 1997.
[20. ] Olivier Wieviorka, Lo sbarco in Normandia, il Mulino, Bologna, 2018, pag. 122-123.
[21. ] Vincenzo Costa, L’ultimo federale, citato, pag. 106.
[22. ] Cfr. Sentenza del processo Saevecke, pag. 41, ove il documento citato, a proposito della strage, dice testualmente: «Nel periodo hanno compiuto molti attentati dinamitardi e terroristici a Milano e dintorni. In risposta, il 10.8.44, quindici detenuti della Polizia di Sicurezza sono stati pubblicamente fucilati in una Piazza di Milano. A fine intimidatorio, i cadaveri sono stati lasciati sulla piazza per un giorno…», senza fare alcun cenno alla pretesa azione di pubbliche relazioni di Costa.
[23. ] Rispettivamente il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, che comprendeva anche la provincia di Lubiana, allora parte integrante del territorio metropolitano.
[24. ] Frederick W. Deakin, La brutale amicizia. Mussolini, Hitler e la caduta del fascismo italiano, vol. II, Einaudi Tascabili, aprile 1990, pag. 748.
[25. ] Ben a Clara, 25 febbraio 1944. ACS, ACP, b. 5, f. 72. Citazione da Mimmo Franzinelli, Il prigioniero di Salò. Mussolini e la tragedia italiana del 1943-1945, Mondadori, Milano, 2016.
[26. ] Ben a Clara, 24 febbraio 1944. ACS, ACP, b. 6, f. 96. Citazione da Mimmo Franzinelli, Il prigioniero di Salò, citato.
[27. ] Lutz Klinkhammer, Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili (1943-44), Universale Donzelli, 1997, pag. 19.
[28. ] Ibidem, pag. 51.
[29. ] Progetto congiunto del governo italiano e di quello tedesco che, attraverso una commissione paritetica di storici di ambo le parti, ha censito e contestualizzato le stragi naziste e fasciste commesse in Italia, nel periodo 1943-45. L’Atlante fa parte di un accordo più complessivo per cui l’Italia rinuncia a ogni rivendicazione, sia essa economica o giuridica, per le stragi naziste perpetrate sul proprio territorio in quel periodo e, in compenso, la Germania finanzia la ricerca storica relativa a quelle stragi.
[30. ] Cfr. ASM, Rapporto Cap. Formosa, citato.
[31. ] Ibidem.
[32. ] Cfr. nota precedente.
[33. ] Cfr. nota 4, pag. 7.
[34. ] Cfr. card. Ildefonso Schuster, Gli ultimi tempi di un regime, citato, pag. 36. Cfr. anche nota 127 a pag. 43 contenuta nella sentenza del processo Saevecke.
[35. ] Ibidem.
[36. ] Vincenzo Costa, L’ultimo federale., citato, Introduzione di G. Parlato, pag. XVII, nota 18.
[37. ] Cfr. V. Costa, L’ultimo federale., citato, pag. 107.
[38. ] G. Pisanò, Storia della guerra civile in Italia 1943-1945, FPE, 1965, pag. 926.
[39. ] Errore di data: cfr. il rapporto del capitano Formosa della GNR, datato appunto 8 agosto 1944, citato.
[40. ] Il camion tedesco, oggetto dell’attentato di ignoti, è parcheggiato dalle 3 di notte, all’altezza del civico 77 di viale Abruzzi, a circa 700 metri da piazzale Loreto. Cfr. il rapporto del capitano Formosa della GNR, citato.
[41. ] Un simile spiegamento di mezzi (alcuni camion) e di uomini (10 militari comandati da un maresciallo) poteva essere deciso almeno da un ufficiale. Ma se anche fosse stata l’iniziativa di un semplice maresciallo, il comunicato del comando della sicurezza tedesca (Saevecke) non avrebbe esitato a farne parola per stigmatizzare l’episodio, mentre, invece, si limita a parlare genericamente di «aggressioni e furti» che sarebbero opera dei «Gap».
[42. ] Cfr. il testo del documento nazista sulla strage di piazzale Loreto citato nella sentenza del Processo Saevecke a pag. 41. La favola dei cinque morti tedeschi (altri dicono tre, sette o nove, secondo la fantasia dello pseudostorico), buttata là con noncuranza negli anni ’60, durerà fino al 1998, quando, finalmente, il processo Saevecke farà piazza pulita di ogni menzogna.
[43. ] Cfr. verbale di riconoscimento dell’Obitorio Civico n. 574/44, datato 8/8/44.
[44. ] Cfr. Piero Parini, Pro memoria urgente per il duce, ASM, CVL, B. 40, fasc. 5, busta 5.
[45. ] Cfr. pag. 25, nota 94
[46. ] Cfr. pag. 25, nota 96
[47. ] Karl R. Popper, La scienza, congetture e confutazioni, in Congetture e Confutazioni, Bologna, Il Mulino, pp. 68-69.
[48. ] luglio-agosto 2005, Il Timone, Vivaio, Piazzale Loreto come via Rasella, 26 aprile 2014/0 Commenti/in Vivaio /da sebamal dal sito: http://www.vittoriomessori.it/blog/2014/04/26/luglio-agosto-2005-il-timone-vivaio/ consultato l’8 aprile 2018.
[49. ] Il tribunale militare di Torino emise la sentenza di condanna all’ergastolo per il criminale nazista Theodor Saevecke in data 9 giugno 1999, ben sei anni prima della data dell’articolo di Messori. La copiosa documentazione (2500 pagine) su cui si basa la sentenza del criminale di guerra è pubblica e, quindi, consultabile con poca fatica.
[50. ] La sottolineatura è mia.
[51. ] Fu Ferruccio Parri a definirla così.
[52. ] La prima edizione del volume The Origins of Totalitarianism di Hannah Arendt è del 1951. Cfr. l’Introduzione di Alberto Martinelli, pag XIII, del volume Le origini del totalitarismo edito da Einaudi nel febbraio 2004.
[53. ] L’unico storico interpellato fu Renzo De Felice e si sarà espresso esclusivamente sul valore documentale del manoscritto, se mai lo fece.
[54. ] Il corsivo è mio.
[55. ] Cfr. Christopher Hale, I carnefici stranieri di Hitler. L’Europa complice delle SS, Garzanti, Milano, 2012, pag. 463.
[56. ] Cfr. L’articolo di Repubblica, Cassazione: Via Rasella fu un atto di guerra. Il Giornale condannato per diffamazione, Roma, 7 agosto 2007, http://www.repubblica.it/2007/08/sezioni/cronaca/rasella-condanna/rasella-condanna/rasella-condanna.html consultato il 18 settembre 2018.
[57. ] Si tratta dei c.d. “Protocolli di Roma”, che furono firmati a Roma, il 7 dicembre 1944, con i quali il CLN-AI fu riconosciuto dagli Alleati. Il testo completo dei protocolli è consultabile in A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI, il Mulino, 1995, pag. 271-272. In seguito a questo importante riconoscimento, anche il governo legittimo del Sud Italia, il 26 dicembre 1944, sottoscrisse il c.d “Trattato delle due Italie” col quale il CLN-AI otteneva la delega a rappresentare il governo legittimo «nella lotta che i patrioti hanno impegnato contro i fascisti e i tedeschi nell’Italia non ancora liberata».
[58. ] Cfr. Renzo De Felice, Rosso e nero, pag. 109, citato.
[59. ] Per Messori, partigiano e comunista sono la stessa cosa. Ignora, o vuole ignorare, che gli antifascismi furono diversi: ci furono quello cattolico delle Fiamme Verdi e delle Aquile Randagie, quello dei liberali come Edgardo Sogno, quello dei comunisti, degli azionisti, dei socialisti e quello dei militari. Solo per citare alcuni nomi, tra i partigiani ci furono militari come Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, azionisti come l’avvocato Pilo Albertelli, e ancora il cattolico Teresio Olivelli con il suo gruppo di “ribelli per amore”, repubblicani, socialisti, comunisti, o indipendenti come Alfredo Pizzoni, alto dirigente del Credito Italiano, che fu presidente del CLN-AI per quasi due anni. Inoltre, ne fecero parte anche diversi sacerdoti come don Pietro Pappagallo, mons. Giovanni Barbareschi, don Paolo Liggeri, solo per citarne alcuni.
[60. ] Cfr. le testimonianze della signora Ferazza e del signor Milanesi già citate.
[61. ] Cfr. il comunicato della sicurezza nazista senza data ma quasi certamente dell’11 agosto 1944, che annuncia l’avvenuta fucilazione e il rapporto a Berlino sulla strage di piazzale Loreto del__.
[62. ] Cfr. il rapporto del capitano Formosa della GNR, datato 8 agosto 1944, e quello del colonnello Pollini della GNR datato 10 agosto 1944. Archivio associazione Le radici della Pace.
[63. ] Luogo nei pressi di piazzale Loreto, in cui i nazisti avrebbero compiuto l’operazione di pubbliche relazioni regalando frutta verdura e altri prodotti alimentari, distante da piazzale Loreto circa 700 metri, e altrettanti dal luogo dell’attentato al camion tedesco dell’8 agosto 1944.
[64. ] Cfr. il rapporto del colonnello Pollini della GNR datato 10 agosto 1944 già citato. Inoltre, confermato dalla fonte più autorevole: il comando della Sipo-SD (cioè il capitano Saevecke) con il suo “Comunicato”.
[65. ] Cfr. art. 159 Codice penale, allora vigente.
[66. ] Doppiogiochista che, d’intesa con Saevecke, progettò e realizzò l’“evasione” di Montanelli dal carcere milanese di San Vittore.
[67. ] Ex partigiano nella formazione cattolica Divisione Valtoce, poi vicepresidente dell’ENI del dopo Mattei e approdato, successivamente, alla Montedison.
[68. ] O, come dice Renata Broggini, “il principe dei corbellatori”, come qualcuno avrebbe voluto intitolare il suo rigoroso libro «Passaggio in Svizzera. L’anno nascosto di Indro Montanelli», edito da Feltrinelli nel 2007
[69. ] Durante il periodo a Nouvelle Italie, Montanelli, nel suo intervento ad un convegno, difese il fascismo enfatizzando il suo ruolo politico di forza antiborghese. Cfr. Carlo Rosselli, Giustizia e Libertà, 30 novembre 1934, citato in Serena Gana Cavallo, Montanelli si indorò la biografia, Italia Oggi, 12 aprile 2016, pag. 14.
[70. ] Cfr. S. Gerbi, R. Liucci, Lo Stregone. La prima vita di Indro Montanelli, Einaudi, Torino, 2006, pag. 29.
[71. ] Cfr. Serena Gana Cavallo, Montanelli si indorò la biografia, citato.
[72. ] Ibidem.
[73. ] Cfr. Enrico Arosio, Montanelli: la doppia vita del grande inviato del Corriere della Sera. Indro, miss Brulator e le SS, in http://forum.laudellulivo.org/index.php/?topic=781.0;wap2 consultato il 23 luglio 2018.
[74. ] Vedi nota precedente.
[75. ] Cfr. Renata Broggini, Passaggio in Svizzera, citato, pag. 29.
[76. ] Cfr. Leo Valiani, Sessant’anni di avventure e battaglie, a cura di Massimo Fini, Rizzoli, 1983, pag. 107.
[77. ] Cfr. Renata Broggini, Passaggio in Svizzera, citato, pag. 73.
[78. ] Cfr. lettera di Giuliana Beltrami Gadola a Vittorio Feltri, direttore de L’Europeo, del 21 giugno 1990. Archivio associazione Le radici della Pace.
[79. ] Ibidem.
[80. ] Cfr. Enrico Arosio, Montanelli: la doppia vita del grande inviato del Corriere della Sera. Indro, miss Brulator e le SS, citato.
[81. ] Montanelli lascia San Vittore il 1° agosto 1944, grazie a un falso ordine di trasferimento per il carcere di Verona di Luca Ostéria, forse avallato da Saevecke e da Rauff. Per un paio di settimane starà nascosto a Milano, presso la signora Muhlbauer, un’amica tedesca di Ostéria, prima di raggiungere la Svizzera il 14 agosto.
[82. ] Archivio dell’Associazione Le radici della Pace – I quindici
[83. ] Tra gli altri, Tino Oldani, Biografie scomode: Montanelli diceva di aver fatto il partigiano, ma a farlo fuggire da San Vittore furono un agente dell’OVRA e una SS, Italia Oggi, 14 aprile 2016, pag. 6.
[84. ] Alberto Custodero e Luca Fazzo, Montanelli testimone SS ma gentiluomo, la Repubblica, 14 maggio 1999, https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/05/14/montanelli-testimone-ss-ma-gentiluomo.html?ref=search consultato il 23.09.2018.
[85. ] Per entrambe le affermazioni, cfr. Storia in Rete, Marcello Staglieno, Indro? Non era un bugiardo, maggio 2008, pag. 56. http://www.storiainrete.com/wp-content/uploads/2008/09/montanelli1.pdf consultato il 26 luglio 2018.
[86. ] Cfr. Cfr. Renata Broggini, Passaggio in Svizzera, citato, pag. 152.
[87. ] C’ Detachement, 78th Section SIB [Special Investigation Branch], C.M. Police. Statement of: Morgante Elena. 4 Apr 46, in ProWo, 310/204. Testimonianza resa a Milano al RSM Vickers J., matricola 14258093. Da Luigi Borgomaneri, Hitler a Milano, citato, pag. 139, note.
[88. ] Cfr. Montanelli, Cervi, L’Italia nella guerra civile, vol. XV, Rizzoli, Milano, anno 2011, pagg. 266-67.
[89. ] G. Schreiber, La vendetta tedesca. 1943-1945. Le rappresaglie naziste in Italia, Oscar Storia, Mondadori, 2001, pag. 127.
[90. ] Cfr. Relazione di maggioranza dell’on. Raisi, di Alleanza Nazionale, della Commissione parlamentare d’inchiesta sui crimini nazisti in Italia, trasmessa alle presidenze di Camera e Senato il 9 febbraio 2006, a pag. 357.
[91. ] Gli incendi prodotti dal bombardamento aereo, richiamando aria dall’area circostante, si autoalimentano bruciando tutto ciò che è infiammabile nell’area, a cui si aggiunge l’ossigeno dell’aria richiamata, raggiungendo così temperature elevatissime. La tempesta di fuoco termina, dividendosi in piccoli incendi, con l’esaurimento di tutto ciò che è combustibile.
[92. ] Cfr. Rapporto GNR 8/8/44 del Cap. Formosa, citato.
[93. ] Vedi nota n. 4 a pag. 7
[94. ] Cfr. Mario Isnenghi, La polemica sull’8 settembre e le origini della Repubblica, in Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni, a cura di E. Collotti, Laterza, 2000, pag. 270, note.
[95. ] Storia della guerra civile – da pag. 926 a pag. 928 – FPE, citato.
[96. ] Cfr. L’ultimo federale, il Mulino, pagg. 107 e 108, citato.
[97. ] Cfr. nota 225 a pag. 42.
[98. ] Ibidem.
[99. ] Cfr. nota 83, pag. 27.
[100. ] Cfr. nota 175, pag. 66.
[101. ] Parini si dimetterà qualche giorno dopo la tragica fucilazione. Ne è prova certa il suo «Pro memoria urgente per il duce» del 10-8-44 (ASM, CVL, B40, f. 5, sf. 5).
[102. ] Cfr. nota 107 a pag. 37.
[103. ] Avvenuto il precedente 20 luglio nella c.d. “Tana del lupo” a Rastenburg.
[104. ] Cfr. la Repubblica, L’amaca di Michele Serra, 20 maggio 2018, pag. 23.
[105. ] Testuale dalla locandina di presentazione del libro da parte di Meravigli Edizioni. Cfr. il sito https://www.meravigliedizioni.it/negozio/meravigli-edizioni/scorci-e-memorie/milano-1944-villa-triste-la-famigerata-banda-koch/. consultato il 26 settembre 2021.
[106. ] Testuale nel primo paragrafo di pagina 72.
[107. ] Numerose le testimonianze in questo senso. Solo per citarne una, monsignor Giovanni Barbareschi che, da semplice diacono, ebbe l’incarico di benedire le salme dei quindici partigiani per conto dell’arcivescovo Schuster. Per questa e altre testimonianze del medesimo tenore, cfr. il film «Partiti per Bergamo», prodotto dall’Associazione «Le radici della Pace», nel 2010.
[108. ] Interrogatorio del dottor Alberto Bettini, Corte d’Assise Straordinaria: atti processuali della sentenza 261/291 del 27/10/45. ASM, Busta 20, fasc. 261 (attualmente mancante per errata archiviazione) e Fondo CAS Milano – vol. 3°.
[109. ] Tribunale Militare di Torino, Atti del processo Saevecke, documento 134-141, pag. 5; oggi nell’archivio del TM di Verona.
[110. ] Cfr. le due note precedenti.
[111. ] Elaborazione personale sulla base dei dati di G. Rochat, Appendice statistica e dati quantitativi, citato, pag. 771 ÷ 773.
[112. ] Oscuro ricercatore del sito dichiaratamente indirizzato a destra www.laltraverita.it (consultato il 30/8/2019) che si definisce “Gruppo di ricerca storica”.
Nella pagina http://www.laltraverita.it/documenti/rappresaglie_partigiane.htm si trova l’articolo di Tosca cui fa riferimento Vespa a proposito della strage di piazzale Loreto, intitolato appunto “Rappresaglie partigiane”.
[113. ] Da me consultato in ed. economica del 2005, pag. 107÷110.
[114. ] Nel senso che abbiamo sempre sostenuto, cioè sulla base della documentazione conosciuta al momento della ricerca.
[115. ] Nel capitolo VII, «Quell’odore di carne bruciata…», gli dedica quattro pagine.
[116. ] Lo si deduce anche dall’errore di Bandini che parlando del prefetto Piero Parini ne storpia il cognome in Barini; errore che è pedissequamente ripetuto da Tosca [alias Ernest Armstrong, cfr. il sito http://www.laltraverita.it/documenti/rappresaglie_partigiane.htm#_ftnref1 consultato il 26 settembre 2021], ma corretto da Vespa nel suo libro.
[117. ] Testimonianza di monsignor Barbareschi, docufilm «Partiti per Bergamo», citato. Quanto le spregevoli modalità di montare la guardia dei militi fascisti abbiano colpito i sentimenti dei milanesi si trova nelle testimonianze della signora Ferazza e del signor Milanesi durante il processo Saevecke. Cfr. carte del processo ora versate al Tribunale militare di Verona.

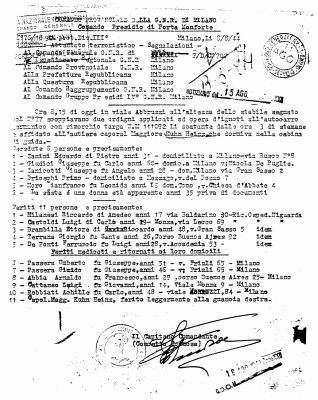 Il rapporto della GNR (trascrizione)
Il rapporto della GNR (trascrizione)